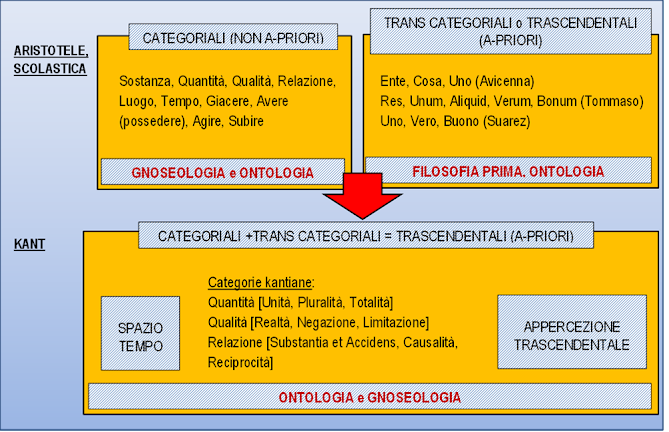1. Ci proponiamo in questo saggio di chiarire il senso originario della nozione di trascendentale in Kant, per come Kant stesso l’ha definita. Per questo abbiamo ritenuto di esaminare dettagliatamente la Introduzione alla CRP del 1787, siglata tradizionalmente come versione B. La precedente introduzione del 1781, la versione A, che era un po’ più breve, era divisa in due sezioni che erano titolate in maniera davvero significativa: I. Idea della filosofia trascendentale e II. Suddivisione della filosofia trascendentale. Evidentemente, per Kant, proprio nell’Introduzione doveva essere esposto il nucleo essenziale della sua nozione di trascendentale. Nei titoli dell’edizione del 1787 il termine “trascendentale” non compare più, tuttavia il contenuto della nuova Introduzione non è radicalmente diverso (sebbene ci siano differenze e molte aggiunte). Per qualche ragione, Kant ha scelto di trattare dunque del suo argomento, la filosofia trascendentale, solo nel testo, prescindendo dalle titolazioni e ripartizioni. Alla fine della Introduzione, in entrambe le versioni A e B, Kant fornisce esplicitamente definizione di “trascendentale” che ha in mente.
2. La Introduzione
alla CRP del 1787 è composta di sette sezioni numerate, ognuna delle quali
possiede un titolo recante una breve sintesi del suo contenuto. La prima
sezione si occupa della distinzione tra la conoscenza
empirica e la conoscenza pura. Kant
ammette subito che la conoscenza comincia sempre con l’esperienza ma insinua anche che non tutte le conoscenze debbano forzatamente
sorgere dall’esperienza: «Potrebbe infatti avvenire che la nostra stessa
conoscenza empirica sia un composto di ciò che riceviamo mediante le
impressioni e di ciò che la nostra facoltà conoscitiva vi aggiunge da sé sola
(semplicemente stimolata dalle impressioni sensibili); aggiunta, questa, che non
distinguiamo da quella materia primitiva, fintanto che un lungo esercizio non
ce ne abbia resi consapevoli, ponendoci in grado di separare i due fattori».[1]
Più chiaro di così. L’ipotesi
che viene sostenuta, proprio in apertura, è che la nostra facoltà conoscitiva
possieda in sé delle conoscenze non
empiriche[2] che essa aggiunge all’esperienza.
Kant parla chiaramente di una “aggiunta” di qualcosa da parte della facoltà
conoscitiva e dunque di un “composto” come risultato. L’esperienza che noi abbiamo deve dunque esser intesa come un composto di elementi proveniente da
fonti diverse. Si tratta inoltre di un’aggiunta della quale non ci rendiamo
conto, che non distinguiamo, fintanto che un lungo esercizio non ce ne abbia resi consapevoli, ponendoci in
grado di separare i due fattori. L’apporto fornito dalla nostra facoltà
conoscitiva al composto non è dunque
consapevole (tanto da far presumere che possa avvenire inconsciamente). Tommaso d’Aquino esprimeva esattamente la stessa
opinione quando osservava che, a causa della abitudine, non ci accorgiamo dell’ens. Ovviamente, anche Tommaso era
proprio sicuro che l’ens ci fosse.[3]
C’è un che di iniziatico in queste
parole che sarebbe errato sottovalutare. L’esigenza di un “lungo esercizio” per
accorgersi di cose di cui nessuno si accorge fa poi venire in mente Husserl e
la sua epoché. Oppure la lunga
formazione speciale che deve avere l’analista secondo Freud. Qui stanno
evidentemente le radici delle filosofie
del sospetto.
Kant dunque pone il
problema – invero onestamente, anche se la risposta è del tutto prevedibile –
se esistano effettivamente siffatte conoscenze a priori. Definendole ulteriormente come conoscenze assolutamente indipendenti da ogni
esperienza. Queste conoscenze sono anche definite come pure, tradendo un certo giudizio negativo per quanto è impuro, cioè il lato materiale dell’esperienza.
Un altro termine usato da Kant è incondizionato.
Risulta chiaro fin dall’inizio, anche se non lo dice esplicitamente, che sono
proprio queste le conoscenze che egli definisce come trascendentali e che la filosofia
trascendentale è vista da Kant proprio come quell’esercizio analitico, “spirituale”,
che ci dovrebbe mettere in grado di separare i due tipi di conoscenza.
Procedimento che poi è sempre del tutto analogo alla reductio di Tommaso.
3. Nella seconda sezione Kant abbandona ogni cautela e afferma
con decisione che noi siamo senz’altro in possesso di conoscenze a priori, o pure, che entrano nel composto
finale della nostra esperienza. Si tratta allora di avere una traccia
evidente che ci consenta di individuarle. Che ci consenta di separare il puro
dall’impuro. Per Kant (e per noi lettori) è davvero fondamentale il criterio
che egli decide di usare per individuare e distinguere quanto vi sia di a priori entro la nostra esperienza.
Secondo Kant, i segni sicuri, gli indizi caratteristici di una conoscenza a priori, sono la necessità e la rigorosa universalità.
L’affermazione è decisamente apodittica e Kant non spende una parola in più per
dimostrare l’assunto. Questo modo categorico di porre la questione è piuttosto
imbarazzante, poiché nel dibattito filosofico del tempo era stato evidenziato
proprio il fatto che la necessità e l’universalità delle conoscenze umane costituivano un problema. Si trattava
del problema per eccellenza di cui stavano discutendo i filosofi più importanti
dell’epoca. Dietro, stava il problema ben noto della fondazione, problema dibattutissimo ai tempi di Kant, ma che aveva
attraversato tutta la filosofia occidentale.
4. La soluzione “trascendentale” di Kant è dunque già tutta
lì: la fondazione dell’esperienza sta in qualcosa
di universale e necessario che noi
stessi aggiungiamo all’esperienza, per lo più senza accorgercene neanche.
Insomma, la necessità e l’universalità stanno in noi. Siamo dunque
noi che rendiamo universale e necessaria la nostra stessa esperienza che,
altrimenti, non avrebbe alcuna fondazione certa. L’obiettivo di Kant è chiaro
fin dall’inizio: fondare la conoscenza in
termini universali e necessari. Questo fa parte del suo progetto, di più
ampio respiro, di costruire la metafisica
come scienza. Chiaramente qui Kant fa a meno di ricorrere a un principio divino, oppure a un intelletto agente, come altri avevano
fatto. La conoscenza umana doveva fondarsi su principi universali e necessari collocati nella mente umana.[4]
Siamo effettivamente in presenza di una laicizzazione:
la mente umana si trova ora ad assolvere a importanti funzioni metafisiche
fondazionali che prima erano state riservate a Dio o a qualche suo delegato.
5. Possiamo facilmente intravvedere, dietro alla questione
della fondazione della conoscenza posta da Kant, il problema annoso della
metafisica di individuare un principio
primo, o una serie di principi primi. Un principio perfettamente auto
evidente. Un principio che non richieda ulteriore dimostrazione. Non si può non
sentire qui l’eco della questione della universalità come l’avevano affrontata
gli antichi, ad esempio con i generi
sommi, oppure come l’avevano affrontata i medievali attraverso la questione
dell’essere necessario. O proprio
attraverso il dibattito plurisecolare sui trascendentali.[5]
Kant apparentemente
finge di venderci una questione
epistemologica e evita di specificare come la sua assunzione circa l’universalità
e la necessità delle conoscenze a priori
che possediamo e riversiamo nella esperienza sia precisamente una assunzione di carattere metafisico. E
sostiene: «Orbene, è facile dimostrare che nella conoscenza umana si dànno
effettivamente simili giudizi, necessari e universali nel senso più rigoroso, e
quindi puri a priori».[6] Da notare
la disinvoltura con cui Kant usa in modo intercambiabile termini come
conoscenza, esperienza e giudizio. Ne riparleremo.
6. Vediamole, allora, queste facili dimostrazioni. Le prove portate da Kant sono costituite da “tutte
le proposizioni della matematica”, le quali appaiono al senso comune dotate di
universalità e necessità. Oppure anche le proposizioni che derivano dalla
fisica, come “ogni mutamento deve avere una causa”. Naturalmente, simili
argomentazioni potevano apparire assai robuste ai lettori di Kant. Oggi lo sono
molto meno.[7] Oppure ancora, Kant sostiene, ahimè, come prova, che queste
conoscenze universali e necessarie sono indispensabili per la possibilità dell’esperienza
stessa: «Donde mai, infatti, l’esperienza trarrebbe la sua certezza se le
regole secondo cui essa procede fossero in ogni caso empiriche, quindi contingenti?
Come potrebbero, in questo caso, fungere da princìpi?».[8] Kant qui assume ciò
che invece dovrebbe dimostrare e cioè la certezza dell’esperienza. Pur
confermando che qui Kant è alla ricerca di principi, l’argomentazione, come
ognun vede, è perfettamente circolare.
Il mondo empirico è contingente, dunque non può generare nulla che sia
universale e necessario. Se abbiamo esperienze che sono (indubitabilmente) universali
e necessarie, allora l’universalità e necessità deve provenire da fuori. Gli
onesti scolastici medievali erano consapevoli e ponevano esplicitamente la necessità del primo
principio, del primo conosciuto,
cioè l’ens. E di tutte le sue
proprietà trascendentali o fondative.
Tra le “facili”
dimostrazioni, Kant propone anche due esperimenti mentali alla Husserl: se dall’esperienza
di un corpo si tolgono tutte le proprietà, resterà tuttavia lo spazio; se a un oggetto empirico si
tolgono tutte le proprietà esperite resterà pur sempre la nozione della sostanza.[9] Forse simili argomentazioni
(che abbondano nella CRP) potevano persuadere i lettori o gli ascoltatori di
Kant. Sono comunque tutte argomentazioni ingenue, dubbie o anche del tutto
sbagliate.
7. A questo punto, nel terzo paragrafo, data ormai per provata la realtà delle nostre conoscenze a priori
universali e necessarie, Kant ipotizza che la filosofia abbia bisogno di
una scienza “che determini la possibilità, i principi e l’ambito di tutte le
conoscenze a priori”. E questo sarà
effettivamente il compito della CRP. Kant continua a suggerire implicitamente
(parla di conoscenze) che si tratta
di una questione epistemologica. In
realtà ha continuato, fin dall’inizio, a giocare sulla ambiguità dei due
termini conoscenza e esperienza.[10] Il suo discorso scivola
continuamente dalla questione della conoscenza alla questione ontologica o
metafisica. Dunque, conclude Kant, la filosofia ha bisogno di una scienza dei trascendentali. Questa nuova
scienza, come ognun vede, è perfettamente analoga alla metafisica di Avicenna,
a quella di Tommaso, o a quella di Duns Scotus. Si tratta di fondare metafisicamente
la possibilità stessa della conoscenza dell’ens
e di tutto quel che consegue.
Tuttavia Kant qui avanza
un’ulteriore motivazione che senz’altro è di notevole rilievo: una scienza
delle conoscenze a priori sarebbe
utilissima per saggiare le pretese di conoscenza di discipline che sogliono abbandonare il terreno dell’esperienza.
Kant propone qui due esempi. L’esempio in positivo è quello della matematica,
la quale può vantare ovunque il suo successo. L’esempio problematico è invece
quello della metafisica, che invece faceva continuamente registrare ampi
disaccordi e insuccessi. Di qui deriverà il vero e proprio carattere di svolta storica
della CRP e cioè il fatto di avere determinato, in termini critici, i limiti
delle metafisiche speciali che
riguardavano l’Anima, il Mondo e Dio. Insomma, l’apporto storico fondamentale
della CRP non sta nella Analitica
bensì nella Dialettica trascendentale.
Non sarà poco, anche se Kant, proprio su questo punto, sarà perfettamente
inascoltato dai suoi successori.
8. Nel quarto paragrafo Kant tratta della distinzione tra giudizi analitici e sintetici. Si tratta qui, nell’intento espositivo di Kant, di
produrre una trattazione più formale a proposito della distinzione, già data
per scontata, tra puro e empirico e della possibile realizzazione
del composto tra i due elementi.
Tratta dunque della sintesi a priori.
Sono tutti argomenti troppo noti per doverli qui riprendere. Segnalo che gli
interpreti di Kant hanno spesso convenuto sulla validità della distinzione tra
analitico e sintetico proposta e utilizzata dallo stesso Kant. Recentemente,
tuttavia, la validità della distinzione è stata messa in dubbio da W.V.O.
Quine, in un suo celebre articolo.[11] Se accogliamo la dimostrazione di Quine,
tutto l’impianto della CRP viene invalidato.
9. Nel quinto paragrafo Kant sostiene che “In tutte le scienze
teoretiche della ragione sono contenuti, come principi, giudizi sintetici a priori”. Cioè, come si è visto,
giudizi che possiedono una componente di conoscenza universale e necessaria a priori o pura. Secondo Kant, i giudizi matematici sono tutti quanti
sintetici (e qui spiega diffusamente la sua concezione della matematica). In
secondo luogo, afferma che anche “La scienza naturale contiene in sé, come
principi, giudizi sintetici a priori”.
Anche nella metafisica, almeno secondo quanto intendono i metafisici, devono
essere contenute conoscenze sintetiche a
priori. Quest’ultima possibilità sarà poi confutata nella Dialettica trascendentale. Matematica,
fisica e metafisica dipenderebbero dunque dagli a priori della Ragione.
10. Ci possiamo domandare perché Kant, in questa rassegna, non abbia
fatto menzione della logica classica,
disciplina che pure conosceva bene, visto che la insegnava. Per Kant la logica
classica aveva in sé un elemento di debolezza. Non aveva alcuna autentica
fondazione metafisica o trascendentale. Come è noto, la fondazione tradizionale
della logica si basava sul principio di
non contraddizione (che in Aristotele aveva anche un valore ontologico). Tuttavia, come anche Aristotele
sapeva benissimo, il principio era indimostrabile. Doveva essere assunto e
basta. Ne derivava che tutti i giudizi logici classici si fondavano su qualcosa
che era, in ultimo, indimostrabile. Nel linguaggio di Kant, la logica classica non era ahimè universale e necessaria, era puramente analitica. Dunque, la logica classica, come insieme delle leggi del
pensiero, non poteva costituire
alcunché, in senso kantiano. La logica classica era semplicemente deduttiva e
non trascendentale!
Per questo Kant compie
una temeraria innovazione: pone una nuova
logica fondata sulla universalità e necessità delle conoscenze a priori. Le
quali apparivano a Kant ben più fondate di quelle della logica aristotelica. La
logica trascendentale si occuperà
così delle conoscenze pure,
universali e necessarie, relative alla sensibilità, all’Intelletto e poi anche delle
Idee della ragione. Dentro alla
esperienza, mescolate con essa, ci sono le conoscenze
pure: due intuizioni pure, 12 categorie e l’appercezione. Dunque, nella
conoscenza restituita dall’Intelletto – che poi è l’esperienza fenomenica
pensata – ci stanno elementi “logici” universali e necessari. Questo significa
che l’intelletto è fuso con il mondo,
con l’esperienza. L’intelletto costituisce l’intelaiatura logica del mondo. Si
tratta dunque – nell’intendimento kantiano – di una logica più profonda di quella aristotelica, capace di regolare non solo il
discorso ma di regolare il Mondo dell’esperienza.
11. In Kant si delineano dunque ben due logiche di carattere diverso. Una logica (quella che sarà detta
trascendentale) si occupa della costituzione stessa della realtà in modo
che questa possa essere conosciuta da noi. Come poi, ad esempio, avverrà
massicciamente in Hegel. Questa logica, come ognun comprende, è di fatto una
vera e propria ontologia. L’altra
logica (quella classica) è una mera tecnica
di derivazione dei giudizi. Così la logica tradizionale perde definitivamente
il suo carattere fondativo, ontologico, poiché questo è già assolto dalle forme
pure universali e necessarie. E diventa semplicemente l’ordine del
ragionamento. Solo con George Boole (1815-1864) la logica sarà poi connessa con
la matematica.
Questa pretesa kantiana,
di una nuova logica che costituisce l’impalcatura
della realtà, sta alla base del plurisecolare conflitto sviluppatosi, nella
filosofia continentale, tra la cosiddetta logica
dialettica e la logica classica.
Saranno gli hegeliani e poi ancora i marxisti (e i francofortesi) a sviluppare
il filone della logica dialettica e a contrapporlo alla logica classica,
considerata una logica di tipo inferiore, legata a un meccanicismo strumentale
e scientista. Ancora un pur grande filosofo italiano come Galvano della Volpe
poteva sognare che la dialettica hegelo marxiana potesse divenire la “logica
delle scienze sociali”.
12. Nel sesto paragrafo, Kant si occupa del problema generale
della ragion pura. E cioè di come siano possibili i giudizi sintetici a priori. Segue la discussione di una
serie di altri problemi ivi impliciti, che qui, per i nostri scopi, possiamo
tralasciare. Finalmente abbiamo il settimo paragrafo, quello conclusivo, dove
compare esplicitamente, nel corpo testuale, anche il termine “trascendentale”.
Il titolo tuttavia è Idea e partizione di
una scienza speciale, denominata Critica della ragion pura. Così Kant ne
spiega l’esigenza: «Infatti la ragione è la facoltà che ci dà i princìpi della
conoscenza a priori. Ragion pura è
quindi quella che contiene i princìpi per conoscere qualcosa prettamente a priori. Un organo della ragion pura
sarebbe un insieme di quei princìpi in base ai quali tutte le conoscenze pure a priori possono essere acquisite ed
effettivamente poste in atto. L’applicazione totale d’un tale organo
costituirebbe un sistema della ragion pura. Ma poiché questo sistema, pur
essendo assai richiesto, lascia ancora aperta la questione se anche qui, ed in
quali casi, una estensione in generale della nostra conoscenza sia possibile,
possiamo allora considerare una scienza della semplice valutazione della ragion
pura, delle sue sorgenti e dei suoi limiti, come la propedeutica al sistema
della ragion pura. Una scienza siffatta non dovrebbe chiamarsi dottrina, ma
soltanto critica della ragion pura; e, rispetto alla speculazione, la sua
utilità sarebbe in realtà solo negativa, poiché servirebbe, anziché all’allargamento,
alla semplice purificazione della nostra ragione, liberandola dagli errori; il
che è di già un grandissimo guadagno».[12]
Quando parla di “organo”
Kant ha ovviamente in mente l’organon
aristotelico. E ha senz’altro in mente che la sua filosofia trascendentale si
appresterebbe a costituire un nuovo
organo, destinato a soppiantare l’organo aristotelico. C’è qui un
accostamento repentino delle conoscenze a
priori, che noi mescoliamo ad altro per generare la nostra esperienza, a un
concetto come quello di Ragione.[13] Si noti la definizione di Ragion pura che
qui è implicita: essa ci fornisce i principi della conoscenza a priori, dunque la ragione entra nella
costituzione stessa della nostra esperienza, nella costituzione di ciò che Kant
chiamerà fenomeno. Il fenomeno è fatto di Ragione mescolata ad
altro. La Ragione produttrice e depositaria di a priori non è più la semplice ragione
discorsiva che calcola le argomentazioni, è bensì una entità che entra
direttamente nella costituzione del Mondo esperito. Una specie di Dio minore
creatore che sta – non si sa come – nella testa dell’uomo. Un intelletto agente
di arcaica memoria. La ragione con le sue conoscenze a priori costituisce effettivamente la intelaiatura di tutto quel
che c’è di esperibile. Si apre la porta qui alla prospettiva hegeliana per cui
la Ragione costituisce la realtà
stessa (= idealismo). Il mondo è razionale perché fatto di ragione. Volendo si può risalire indietro fino ad Avicenna
(980-1037).
13. A questo punto (siamo giunti ormai a metà del par. VII, l’ultimo)
Kant spiega esplicitamente cosa intenda con la nozione di trascendentale. «Chiamo trascendentale
ogni conoscenza che si occupi, in generale, non tanto di oggetti quanto del
nostro modo di conoscere gli oggetti nella misura in cui questo deve essere
possibile a priori. Un sistema di tali concetti potrebbe esser
detto filosofia trascendentale».[14] La
filosofia trascendentale, nell’intento
di Kant, si occupa dunque dei principi a
priori che rendono possibile la costituzione
della realtà e, dunque, anche la sua conoscenza. La realtà fenomenica per Kant
è costituita in quanto vien conosciuta. Ma la costituzione deve precedere la conoscenza. La filosofia
trascendentale si occupa in altri termini esattamente
di ciò che i medievali chiamavano transcendentalia.
Solo “nella misura in cui” questi sussistano effettivamente. Ma Kant ha già
mostrato che sussistono. Senza i principi a
priori della Ragione, niente filosofia trascendentale. Ma anche niente
esperienza. Niente realtà fenomenica. La filosofia trascendentale è dunque
strettamente legata alla sintesi a priori.
Infatti la domanda fondamentale cui tenterà di rispondere la CRP è proprio come questa sia possibile. Per i
medievali, i transcendentalia erano
le proprietà profonde della creazione divina, i principi primi che costituivano l’ens creato e lo rendevano intelligibile. La filosofia
trascendentale medievale era l’erede della filosofia prima, la scienza dell’ente in quanto ente. Ora,
in Kant, la filosofia trascendentale è la scienza dei principi primi a priori grazie ai quali la Ragione costituisce il mondo.
14. Nel proseguimento della CRP Kant userà spesso il termine
trascendentale (anche se con sfumature di significato talvolta piuttosto
diverse)[15] senza più fornire alcuna ulteriore spiegazione, presupponendo
evidentemente che al suo lettore sia bastata la definizione fornita nella
introduzione. Tuttavia a un certo punto ritornerà esplicitamente sulla
questione. Nella Logica trascendentale,
dopo avere presentato la tavola delle sue nuove categorie, ricavate anche ma
non solo dalle categorie aristoteliche, quasi come per prevenire l’obiezione di
avere trascurato qualcosa, Kant afferma quanto segue: «Nella filosofia
trascendentale degli antichi si trova però ancora un capitolo comprendente
concetti puri dell’intelletto, i quali, pur non rientrando nell’elenco delle
categorie, dovevano tuttavia valere come concetti a priori degli oggetti; ma in effetti essi accrescerebbero in tal
modo il numero delle categorie, il che non è possibile».[16]
Si noti che qui Kant
chiama concetti puri dell’intelletto
proprio i trascendentali medievali. Cioè concetti che non sono ricavati dalla
esperienza ma che sussistono di per sé dentro l’Intelletto. Avrebbe anche potuto
dire a priori. Più chiaro di così!
Pur essendo il loro elenco variato assai nel corso della storia filosofica,
Kant, proseguendo, si limita a citarne solo tre: «Essi sono racchiusi nella
proposizione tanto celebre presso gli scolastici: quodlibet ens est Unum, Verum, Bonum. Benché l’uso di questo
principio, a giudicare dalle conseguenze (che altro non produssero se non
proposizioni manifestamente tautologiche), abbia avuto un risultato miserevole
al punto che ai nostri tempi la metafisica suole farne menzione quasi solo per
deferenza – tuttavia un pensiero che ha resistito così a lungo, per vuoto che
sembri, è pur sempre degno di un’indagine circa la sua origine e rende lecita
la supposizione che trovi il suo fondamento in qualche regola dell’intelletto,
sottoposta, come spesso accade, a una falsa interpretazione».[17] Insomma, Kant
s’interroga circa la persistenza della tematica dei trascendentali nel corso
della storia della metafisica occidentale e sospetta che, dietro a questa
persistenza, possa esserci eventualmente qualcosa. La tavola, peraltro assai
mutevole, dei vecchi trascendentali non collimava senz’altro con la sua, appena
presentata.
15. Kant così svela esplicitamente al lettore quale sia l’arcano
che sta dietro alla terminologia dei trascendentali, sostenendo che i veri trascendentali sono i suoi, quelli
che ha appena finito di elencare e che i trascendentali degli antichi erano
dovuti a una prospettiva errata. La prospettiva errata consisteva nel fatto che
i trascendentali erano stati considerati anche
come proprietà delle cose e non soltanto della mente. Spiega così che: «Questi
presunti predicati trascendentali delle cose altro non sono che esigenze e
criteri logici di ogni conoscenza delle cose in generale, a fondamento della
quale essi pongono le categorie della quantità che sono: unità, pluralità e
totalità. Ma queste categorie, che avrebbero dovuto esser prese effettivamente
in senso materiale, come proprie della possibilità delle cose stesse, gli
antichi le assunsero in effetti soltanto nel significato formale, come proprie
dell’esigenza logica relativa ad ogni conoscenza, tuttavia considerando
incautamente questi criteri del pensiero come proprietà delle cose stesse».[18]
La argomentazione
kantiana è decisamente un poco contorta. Ho messo in nota anche la traduzione
di Esposito. Comunque il senso è abbastanza chiaro. L’errore degli antichi
sarebbe consistito nel negare il
carattere esclusivamente mentale/ formale dei trascendentali e soprattutto
nel negare il loro carattere costitutivo
dell’esperienza. Secondo Kant i tre principali trascendentali degli antichi
sarebbero riconducibili alle sue nuove
categorie della quantità, che invece hanno carattere mentale e costitutivo.
Gli antichi invece considerarono i trascendentali sia come entità logiche (pertinenti l’intelletto) sia
come entità ontologiche (pertinenti
tutte le cose). Questo poiché essi condividevano (stupidamente, dal punto di vista di Kant) una teoria della verità come corrispondenza. Per Kant,
dopo la sua “rivoluzione copernicana”, la teoria della verità come
corrispondenza vale solo dentro il fenomeno. La verità non può che rispecchiare circolarmente ciò che la
mente ha già a priori dentro di sé e
che ha appena messo nel fenomeno.
16. Insomma, per Kant l’erronea dottrina medievale dei
trascendentali sarebbe derivata dal fatto che i medievali non conoscevano ancora la filosofia di Kant, e quindi finirono per
collocare oggettivasmente nelle cose quelli che invece per Kant sono soltanto
dei criteri della conoscenza, degli a
priori della Ragione. In effetti, nel seguito del testo citato, Kant ritiene di
mostrare come i tre trascendentali che ha riportato possano essere facilmente
ricondotti alle categorie della quantità, nella nuova tavola delle categorie
che egli ha appena presentato.
Kant può permettersi di
far questo perché – dopo la sua “rivoluzione copernicana” – non ha più bisogno
di un qualche diverso fondamento dell’ens.
Il fondamento c’è già. Le categorie kantiane hanno già preso il posto dell’ens (e dei suoi modi) e ora, dalla loro
collocazione come a priori, possono
svolgere la vecchia funzione fondazionale dei trascendentali medievali (motivo
per cui il loro nome è rimasto ed è stato addirittura valorizzato). La
preoccupazione di Kant, che aveva appena finito di ricavare i concetti puri
dell’intelletto dalla tavola dei giudizi della logica tradizionale, era quella
di rassicurare che il suo elenco fosse
completo e che non fosse il caso di aggiungere, come ulteriori concetti
puri, qualcuno dei trascendentali medievali.
17. Considerando il rapporto tra i trascendentali kantiani e
quelli medievali possiamo accorgerci – oltre a una loro sostanziale analogia –
di un fatto abbastanza sorprendente ma non troppo: quello che Kant presenta al
suo lettore è esattamente uno scivolamento
delle categorie tradizionali dentro i transcendentalia. Kant provvederà
cioè a mescolare nelle sue forme a priori entità che nella filosofia scolastica
precedente erano state accuratamente
tenute distinte. Nella fig. 1, in appendice, abbiamo realizzato una
rappresentazione grafica della situazione. I trascendentali medievali erano transcategoriali (situati cioè al di là
delle categorie) e svolgevano un compito opposto
a quello delle categorie. Mentre le categorie presiedevano alla distinzione, servivano cioè per descrivere
la varietà del mondo sensibile, i trascendentali identificavano invece i caratteri comuni dell’ens, erano perciò il presupposto di
qualsiasi conoscenza (ed erano a-priori,
posti dentro a tutte le cose!). Visto con gli occhi del medioevo e della
Scolastica, il procedimento kantiano doveva apparire estremamente familiare,
seppure alquanto velleitario. Dietro al problema della sintesi a priori gli scolastici non potevano non scorgere ancora il
vecchio problema della metafisica: di connettere le conoscenze provenienti dal
mondo sensibile, attraverso i sensi, con una serie di conoscenze a priori
(considerate cioè come non derivanti dalla esperienza, i trascendentali,
appunto). Il problema era sempre quello di cui già si trattava nel De anima aristotelico: come l’intelletto
potesse cogliere la forma intelligibile presente nelle cose.[19] Il problema
era passato, nel neoplatonismo e poi in Avicenna. E poi via di seguito, fino a
Suarez e poi ai metafisici del Seicento e del Settecento.
18. Il progetto kantiano doveva apparire velleitario perché se
c’era qualcosa che era sempre rimasto fermo nella lunga storia dei transcendentalia era la distinzione rigorosa tra i trascendentali da una parte e le categorie aristoteliche dall’altra. I
trascendentali, anche nel nome, non erano categorie, non potevano essere
categorie, proprio perché, per svolgere il loro compito, andavano necessariamente
oltre le categorie! I trascendentali
avevano il compito fondazionale, svolgevano un ruolo fondativo della filosofia
prima, della metafisica elementare (metaphysica
generalis). Dal punto di vista degli scolastici, si trattava dunque di
mettere i transcendentalia della metphysica generalis (quale che fosse
effettivamente il loro elenco) a fondamento primo a priori dell’uso delle categorie
aristoteliche, le quali tuttavia mantennero sempre la loro autonomia, non
furono mai contestate perché presiedevano ad assicurare la conoscenza umana del mondo e rispecchiavano l’ordine del mondo sensibile. Per Aristotele poi, nessuna sostanza
poteva essere conosciuta a priori.[20]
Per lui la sostanza prima era il sinolo! La ricerca dei principi a priori
era stata introdotta in seguito alla platonizzazione di Aristotele e al suo
adattamento al pensiero cristiano. Kant, come s’è visto, ha cercato di fare
sostanzialmente la stessa cosa degli scolastici. Con un piccolo grande
problema. Vogliamo chiamalo errore? O vogliamo chiamarlo fallacia, come fa Maurizio Ferraris?[21]
19. La fallacia fondamentale sta in questo: Kant nella CRP –
nella Estetica trascendentale e nella
Analitica trascendentale – ha messo anche le categorie (alcune tra quelle
più importanti) dentro i transcendentalia.
Così lo spazio e il tempo (ma anche la qualità, la quantità, la sostanza, e
altro ancora, come la causalità che – si noti bene – per Aristotele non era
affatto una categoria), che erano le forme volte alla conoscenza del mondo
sensibile e non alla metafisica, diventano ora conoscenze a priori universali e necessarie. Un pasticcio davvero
ragguardevole. Ciò significherà considerare le proprietà fondamentali delle
cose del mondo come degli a priori metafisici
residenti nell’Intelletto. Il risultato sarà, com’è noto, la mentalizzazione del Mondo. Il mondo così
diventerà compiutamente mind dependent.
Questa scelta, come è noto, darà vita alla prospettiva dell’idealismo trascendentale. E a tutte le successive
filosofie “trascendentali” dell’Ottocento e del Novecento.
20. È facile oggi comprendere, per noi, come, da questa fallacia trascendentale, siano derivati
i tratti fondamentali della filosofia
continentale, nei due secoli successivi e più. Dopo Kant, i filosofi
continentali (tranne pochi) non dubiteranno più che ci siano degli a priori. E, soprattutto, non faranno
altro che continuare a domandarsi, seppure in modalità assai diverse, quali
siano i veri a priori (sulla base di
ciò che, di volta in volta, sarà ritenuto, più o meno arbitrariamente, come universale e necessario o, se si vuole, fondativo).
Quali siano cioè, ancora, i veri transcendentalia
che costituiscono il mondo. In
proposito, dopo avere violato, grazie a Kant, i confini tra metafisica fondazionale e fisica del mondo naturale, poteva venir
fuori qualsiasi cosa. L’elenco di supposti trascendentali che sono stati
mescolati col mondo entro improbabili sintesi
a priori è davvero lungo, e ancora in continua crescita. Ne riporto qui un
elenco esemplificativo: l’Io, l’Idea, lo Spirito, l’essere, la volontà, la
vita, la libertà, la volontà di potenza, la storia, la struttura, la materia
economico sociale, l’alienazione, la merce, l’ego trascendentale, il testo o la
testualità, il potere, il linguaggio, l’interpretazione, l’esistenza, il nulla,
la tecnica, il desiderio, la libido, l’inconscio, la ragione strumentale. Si
noti anche che alcune filosofie continentali, resesi forse conto della
sterilità delle loro pratiche, non hanno trovato di meglio che vivere di
rendita, raccontando e celebrando proprio la annunciata sparizione dell’a priori dal mondo. Così abbiamo avuto
la fine della verità, la fine del soggetto, la fine della storia, l’eclissi
della ragione, la morte di Dio, la sparizione dell’Essere, la fine della
metafisica, la morte dell’Occidente e quant’altro. Una sorta di nichilistico lutto permanente in memoria della
scolastica kantiana perduta.
APPENDICE
Fig.1 – Lo
scivolamento progressivo dei categoriali aristotelici nei trascendentali
kantiani.
Giuseppe Rinaldi (30/06/2025)
OPERE CITATE
2012 Aertsen, Jan A., Medieval Philosophy as Transcendental Thought. From Philip the Chancellor (ca. 1225) to Francisco Suárez, Brill, Leiden.
1966 Aristotele, Anima (A cura di Giancarlo Movia), Rusconi Libri, Milano.
2001 Ferraris, Maurizio, Il mondo esterno, Bompiani, Milano.
2004 Ferraris, Maurizio, Goodbye Kant! Cosa resta oggi della Critica della ragion pura, Bompiani, Milano.
2014 Kant, Immanuel, Critica della ragion pratica e altri scritti morali (A cura di Pietro Chiodi), UTET, Torino. [1787]
2004 Kant, Immanuel, Critica della ragion pura (A cura di Costantino Esposito), Bompiani, Milano. [1781/ 1787]
1992 Kemp Smith, Norman, Commentary to Kant’s “Critique of Pure Reason”, Humanities Press International Inc,, Atlantic Highlands, NJ. [1918- 1923]
1953 Quine, Willard van Orman, From a Logical Point of View. Nine logico-Philosophical Essays, Harvard University Press, Cambridge. Tr. it.: Da un punto di vista logico. Saggi logico-filosofici, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004.
NOTE
[1] Cfr. B2. In questo commento, a meno di altra segnalazione, seguo la traduzione di Chiodi.
[2] Non
empiriche non vuol dire necessariamente innate.
Ogni specie di uccelli sa come fare il nido, ma questa non è una conoscenza a priori nel senso di Kant. La non empiricità per Kant è una nozione
metafisica che ha a che fare con la Ragione.
[3] Questo atteggiamento, di postulare l’esistenza
necessaria di cose di cui nessuno si accorge, è tipica della visione
trascendentale.
[4] Sottolineo che oggi la semantica di “mente”
non corrisponde a ciò che intendeva Kant. Nei suoi scritti latini aveva usato animus. Solitamente usa il termine Gemüt. In Italiano è stato tradotto
anche come Spirito da Gentile e
Lombardo - Radice. Mente porta con sé
una connotazione cognitivista che è assolutamente estranea a Kant.
[5] Su questo punto si veda Aertsen 2012.
[6] Cfr. B4.
[7] Il dibattito circa i fondamenti della
matematica è oggi quanto mai aperto. E la maggioranza degli studiosi non sembra
concordare con Kant.
[8] Cfr. B5.
[9] Qui Kant fa un uso comune dei termini spazio e sostanza ed evita ogni definizione rigorosa. Sull’uso allegro che
Kant fa di queste nozioni si veda il mio saggio Finestre
rotte: La chiocciola di Kant e altre storie spaziali.
[10] Su questa ambiguità ha recentemente
insistito Maurizio Ferraris. Cfr. Ferraris 2001 e la questione della ciabatta.
[11] Cfr. Quine 1953. L’articolo in questione è
titolato Due dogmi dell’empirismo.
[12] Cfr. B25.
[13] In questa fase introduttiva Kant,
comprensibilmente, non distingue ancora tra Intelletto e Ragione.
[14] Cfr. B25.
[15] Sui diversi usi kantiani di “trascendentale”
si veda Kemp-Smith 1992.
[16] Kant, CRP, B113 e segg.
[17] Kant, CRP, B113 e segg.
[18] Kant, CRP, B114 e segg. Traduzione Chiodi.
La resa nelle traduzioni disponibili in italiano è piuttosto contorta. Riporto
la traduzione di Esposito: «Questi presunti predicati trascendentali delle
cose, non sono altro che delle esigenze e dei criteri logici di ogni conoscenza
delle cose in generale, e pongono a fondamento di questa conoscenza le
categorie della quantità, vale a dire l’unità, la pluralità e la totalità.
Sennonché, queste categorie, che avrebbero dovuto essere intese in senso
propriamente materiale, e cioè come appartenenti alla possibilità delle cose
stesse, in realtà furono intese dagli antichi soltanto in senso formale, come
appartenenti all’esigenza logica che riguarda ogni conoscenza, sebbene poi essi
trasformarono incautamente questi criteri del pensiero in proprietà delle cose
in se stesse».
[19] Cfr. De
Anima, III, 4 e III, 5.
[20] A meno che non si voglia invocare qui l’intelletto potenziale. Il quale potrebbe
avere dentro di sé, in potenza, qualsiasi cosa, ma se resta in potenza e non si
attua è come se non ci fosse. A dire il vero, la teoria dell’intelletto
contenuta nel De Anima non è tra le
più chiare.
[21] Cfr. Ferraris 2004.
.