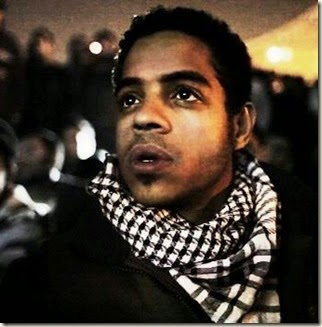Maidan è un nome di origine araba (con molte diverse accezioni, come maydan, midan, meydan o majdan) che significa «piazza».[1] Nella storia recente si è parlato alquanto di Midan Tahrir del Cairo, oppure di Maidan Nezalezhnosti di Kiev. In molti altri paesi (India, Iran, Afghanistan, Polonia, Serbia, Siria, Turchia, ma anche in Georgia o nello Yemen) ci sono molte maidan, nelle principali città. Le maidan sono salite agli onori delle cronache perché hanno ospitato molti movimenti di protesta e molte delle ormai ricorrenti rivoluzioni che hanno interessato un’ampia fascia di paesi arabi (le cosiddette “primavere arabe”), ma anche alcuni paesi dell’ex Unione sovietica e alcune realtà del Sud America come il Venezuela o il Brasile. Movimenti dello stesso tipo non sono mancati neanche nei paesi più avanzati, sebbene qui le manifestazioni siano state meno eclatanti: basti pensare a Occupy Wall Street, al movimento degli indignados spagnoli, oppure, in Italia, ai fatti del G8 genovese, oppure al movimento dei NOTAV nella «piazza» della Val di Susa.
Questi movimenti di protesta e/o rivoluzioni, soprattutto quelli localizzati in paesi economicamente arretrati o in paesi dai sistemi politici autoritari, sono stati in genere salutati favorevolmente dalle opinioni pubbliche dei paesi democratici occidentali. In particolare, è stata manifestata una grande solidarietà nei loro confronti quando le piazze sono state oggetto di repressioni violente. In taluni casi l’Occidente si è adoperato attivamente, attraverso i più diversi strumenti,[2] seppure in un quadro di politiche internazionali assai confuse, per sostenerli e favorirne lo sviluppo. L’opinione pubblica dei paesi occidentali si è perfino spesso divisa intorno alla questione se intervenire o meno con strumenti militari a favore degli insorti, per contrastare la repressione. I movimenti e le rivoluzioni che avvengono nelle piazze in fondo piacciono perché ci sembrano genuini, spontanei, popolari, democratici. Siamo generalmente disposti a sostenerli, fintanto che tutto ciò non si ripercuota sul nostro portafoglio, in termini di tasse, di perdita di esportazioni o di aumento dei prezzi del petrolio.
Che le multiformi maidan siano ormai diventate un panorama fisso del quadro internazionale è testimoniato dal fatto che si sta costituendo uno strato sociale di militanti e/o combattenti che è disponibile a spostarsi, a girare per il mondo, per intervenire direttamente nelle situazioni più calde. Da questo punto di vista (e, sia ben chiaro, solo da questo punto di vista), non c’è alcuna differenza tra Femen, Greenpeace, Black Block o militanti di al Quaeda. Nella storia ci sono sempre stati militanti/ combattenti disposti a mettere il proprio braccio, più o meno armato, al servizio di una causa, per motivi ideali o anche solo in cambio di una retribuzione. Si va da uomini illustri, come il generale La Fayette o Garibaldi, fino a schiere di generosi e sconosciuti combattenti, come gli uomini delle Brigate internazionali nella Guerra civile spagnola, fino alla odierna ridda di militanti delle più disparate cause, composta da molti individui dalle più nobili motivazioni, ma anche da avventurieri, ex spie, ex legionari e contractors prezzolati, che si confondono talvolta con la criminalità comune. Si assiste, insomma, soprattutto negli ultimi decenni, a una vera e propria internazionalizzazione e globalizzazione di questi militi vaganti, la cui attività trova il terreno ideale proprio sulla scena delle piazze del mondo, come se il mondo stesso si fosse trasformato in una piazza globale. Questi fenomeni peraltro sembrano destinati ad aumentare più che a diminuire.
Le odierne «rivoluzioni nelle piazze», per quanto non abbiano risparmiato alcuni paesi economicamente sviluppati, sono avvenute per lo più in paesi che hanno guadagnato l’autonomia nazionale in tempi relativamente recenti (i nomi rispettivi della piazza di Kiev e di quella del Cairo hanno proprio il significato di “Piazza dell’Indipendenza”). Si tratta di paesi che, dopo aver guadagnato l’indipendenza ed essersi costituiti come Stati nazionali, hanno tuttavia subito, talora per decenni, il governo da parte di regimi poco o nulla democratici, spesso autoritari e corrotti. Questi possono appoggiarsi al potere religioso, oppure possono anche essere di natura laica. Possono essere tipicamente catalogati come 1) monarchie tradizionali, 2) dittature laiche, 3) regimi pseudo-democratici. Taluni di questi regimi godono dell’appoggio di grandi potenze straniere oppure, anche se più raramente, tendono all’isolamento, a scagliarsi contro tutto ciò che è straniero. Si tratta evidentemente di paesi che stanno attraversando una crisi di crescita, paesi che sono sulla via della modernizzazione, che stanno cercando una loro specifica via di modernizzazione. Si tratta di Paesi gravemente spaccati al proprio interno tra coloro che vorrebbero correre molto velocemente con le riforme e coloro che vorrebbero mantenere inalterato lo statu quo.
Un motivo conduttore delle riflessioni degli studiosi intorno a questa nuova ondata di rivoluzioni riguarda la questione delle cause. Perché tutte insieme? La loro concomitanza, seppure in un quadro di grande diversità, ha suscitato non poco stupore. Cosa c’entrano tra loro l’Ucraina, la Siria, la Libia e il Venezuela? Alcuni studiosi hanno individuato, nella storia globale recente, una serie successiva di ondate di democratizzazione che sono state ben documentate. Finora si era giunti a individuare tre successive ondate.[3] Forse siamo ora in presenza dei prodromi di una quarta ondata. Alcune delle precedenti ondate sono piuttosto facili da spiegare nelle loro linee generali, ad esempio quella della decolonizzazione concomitante e/o successiva alle due guerre mondiali. La nostra attuale possibile quarta ondata sembra piuttosto dovuta a difficoltà comuni che società molto diverse tra loro attraversano nel loro processo di modernizzazione, a confronto con un contesto globale che è sempre più presente e condizionante.
Nel tentativo di individuare le cause specifiche, come al solito si rincorrono e vengono messe in competizione le spiegazioni di tipo socio economico e quelle di tipo più propriamente politico culturale. A questo proposito, occorre in linea generale correggere l’opinione, risalente a un inveterato economicismo, secondo cui queste rivoluzioni starebbero avvenendo a causa del peggioramento delle condizioni sociali ed economiche. Non pare proprio così o, se si preferisce, il peggioramento della situazione economica è solo una parte della questione. Le rivoluzioni delle piazze possono nascere proprio quando la gente sta meglio e comincia a rivendicare, accanto alla soddisfazione dei bisogni elementari, anche la soddisfazione di bisogni meno impellenti, come quelli di una democrazia politica. Sembra in proposito che sia all’opera su vasta scala un meccanismo di privazione relativa, derivante dal contrasto tra il benessere raggiunto e la percezione dell’oppressione. Solo quando si ha un certo benessere si può cominciare a considerare insopportabile l’oppressione politica.
Proprio per questo stesso motivo però, in questi casi, non tutti i gruppi sociali si mobilitano contemporaneamente. Tendono a mobilitarsi più facilmente i giovani (in genere più istruiti), gli intellettuali, il ceto medio. La popolazione rurale e il sottoproletariato, soprattutto se egemonizzati dalla cultura religiosa, unitamente alle élite tradizionaliste, tendono ad assumere invece posizioni conservatrici. Se poi la popolazione è suddivisa in clan o etnie la mobilitazione può dipendere anche dalla posizione che queste hanno rispetto alla società globale (ci possono essere etnie favorite, oppure svantaggiate o addirittura emarginate e perseguitate). Questo quadro di diversa percezione della privazione relativa fa sì che, in rapporto alla modernizzazione, si sviluppino – in un modo o nell’altro – profonde lacerazioni sociali interne che possono andare ben oltre il confronto culturale o politico e possono sfociare in violenze, guerre civili o secessioni.
La politica estera opportunistica delle grandi potenze ha contribuito non poco a fossilizzare le situazioni interne di molti di questi paesi. Si tratta di paesi che spesso hanno importanza strategica, oppure che sono fonti di materie prime. Le grandi potenze hanno spesso riconosciuto (e spesso aiutato) le élite del potere anche quando erano del tutto impresentabili. Ciò ha permesso a queste stesse élite di restare a lungo al potere e di perfezionare i loro regimi autoritari. Sotto le cappe dell’oppressione, queste società si sono comunque lentamente sviluppate, seppure in condizioni di forte disuguaglianza interna. Anche i regimi più autoritari non hanno potuto impedire di introdurre sistemi di trasporti, mezzi d’informazione, servizi sanitari, burocrazia, sistemi di istruzione. Non hanno potuto impedire un certo sviluppo dell’urbanizzazione (non a caso le città e le loro piazze tendono a diventare l’epicentro del nuovo conflitto politico). Non hanno potuto impedire lo sviluppo di qualche processo di secolarizzazione. Insomma, queste società possiedono al loro interno strati sociali che si sono modernizzati e che mal sopportano la presenza delle élite estrattive che solitamente detengono arbitrariamente il potere, che solitamente sono alquanto corrotte, alimentano il sottosviluppo economico e le disuguaglianze, rifiutano i criteri del merito, bloccando la mobilità sociale, alterano le regole del mercato, godono dell’appoggio di componenti tradizionaliste e/o reazionarie.[4] Indubbiamente, com’è stato rilevato da molti osservatori, lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione ha senz’altro fornito un elemento in più volto ad incoraggiare la domanda di cambiamento da parte dei più impazienti.
Che le cause comuni autentiche siano profonde ed endemiche è reso evidente dal fatto che, invece, le cause scatenanti delle piazze siano state le più diverse e talvolta le più insignificanti. È stato più volte accertato che l’inizio delle proteste è stato occasionale (ad esempio, in Tunisia la protesta ha preso avvio dal suicidio di un venditore ambulante; in Turchia, a Istanbul, la difesa degli alberi del Gezi Park ha fatto crescere, nella maidan Taksim, un movimento così forte da far tremare il regime; in Ucraina la recente rivolta è scoppiata sulla questione della stipulazione di un trattato con la UE). In seguito al fatto scatenante, quale che sia, si manifesta inaspettatamente una corrente collettiva, un’indignazione superiore perfino al merito stesso delle questioni. Il fatto scatenante è percepito come un emblema della situazione generale di oppressione, ci si mobilita per qualcosa di specifico, ma l’obiettivo specifico rinvia continuamente a qualcos’altro. L’auto riconoscimento dell’esistenza di un movimento avviene nella situazione di piazza e i partecipanti stessi sono solitamente sorpresi dall’ampiezza della partecipazione. Lo stesso vale per le forze dell’ordine, le quali non si rendono immediatamente conto di ciò con cui hanno a che fare.
Di solito in questi Paesi non esiste un’opposizione organizzata funzionante, men che mai un’opposizione rivoluzionaria. Spesso le opposizioni organizzate sono indebolite o annientate dalla repressione del regime al potere. Non c’è neppure un’opposizione rivoluzionaria armata, poiché queste sono tipiche dei paesi più arretrati, dove spesso la popolazione non è in grado di ribellarsi autonomamente e dove l’iniziativa rivoluzionaria viene spesso presa da élite rivoluzionarie di importazione esterna (si pensi alla Bolivia del Che Guevara).[5] Quindi, nei casi di cui ci stiamo occupando, è stato essenziale, per lo scoppio della rivolta in piazza, che le masse si siano ritrovate per qualche motivo di protesta, anche futile, in uno spazio pubblico - una maidan appunto. In genere, quindi, si tratta di città piuttosto grandi, spesso è la capitale, e il popolo della piazza è un composto, certo variegato, soprattutto di giovani, di appartenenti a gruppi intellettuali, di ceto medio. È la presenza fisica in piazza a far scattare un meccanismo di auto riconoscimento e di presa di coscienza, a infondere fiducia: siamo in tanti, ce la possiamo fare.
Si tratta spesso dunque di opposizioni non organizzate che sono originate dalla disponibilità alla mobilitazione degli strati sociali che le alimentano e dalla loro stessa azione spontanea. Se trattasse di opposizioni organizzate, la loro presenza fisica in piazza avrebbe potuto essere facilmente prevenuta e impedita dagli apparati repressivi.[6] La nuova dimensione di movimento pubblico crea un certo sconcerto anche tra i repressori. I moderni mezzi d’informazione limitano, infatti, le capacità repressive e l’uso degli strumenti repressivi tradizionali. Le imprese di repressione devono sempre più essere tenute accuratamente nascoste, poiché ogni piccolo evento acquista dimensione globale. I regimi autoritari devono tenersi buoni i loro amici occidentali e non possono farsi mettere alla berlina sui giornali e su Internet in tutto il mondo. Soprattutto se la protesta delle piazze è pacifica, se vengono segnalate violazioni dei diritti umani.
Come si è detto, dunque le «rivoluzioni nelle piazze» sono, in genere, rivolte improvvisate, non dirette da organizzazioni consolidate. I manifestanti comprendono che il carattere pubblico dello spazio conquistato è una risorsa fondamentale - forse la loro unica risorsa. Per questo le piazze diventano degli accampamenti fortificati da difendere. Per questo la parola d’ordine è quella di resistere, mantenere la posizione, non allontanarsi, piantare le tende, bivaccare giorno e notte. Per questo il problema delle forze dell’ordine diventa quello di sgomberare la piazza, senza tuttavia mostrare al mondo di compiere atti liberticidi o atti violenti contro dimostranti pacifici. Si assiste così, di fronte ai reporter di tutto il mondo, al balletto delle dimostrazioni di forza, degli incidenti, delle tregue e delle trattative. Uno degli strumenti più disastrosi, in queste situazioni, è l’organizzazione di contro manifestazioni da parte di elementi moderati o estremisti, oppure, peggio, l’organizzazione di squadroni di irregolari, privi di qualunque ufficialità, che possono operare a loro piacimento contro la piazza. Si va dai cecchini che dai tetti tirano a caso sulla folla, agli squadroni che catturano, pestano e torturano i leader individuati. Le immagini che ci sono giunte dall’Ucraina, di bande paramilitari senza insegne e segni individuali di riconoscimento, di incappucciati che organizzano posti di blocco, fanno perquisizioni, assaltano i palazzi delle istituzioni, sono esemplari. In simili situazioni, il passaggio alla guerra civile è piuttosto facile. È sufficiente che una frazione della piazza decida a sua volta di armarsi e rispondere colpo su colpo.
Poiché il movimento di solito nasce da fatti occasionali, non pianificati, esso è sempre profondamente impreparato e disorganizzato (anche se dispone di notevoli risorse fondate sulla mobilitazione spontanea e creativa di centinaia di migliaia di persone). Naturalmente, nel momento in cui si costruisce il movimento, si determina uno stato di effervescenza collettiva, uno stato di fusione. La prima sensazione è quella di una forte unità, capace di abbattere tutte le differenze.[7] Gli eventi che avvengono sotto gli occhi di tutti chiariscono le idee anche ai più titubanti e indecisi, si manifesta così una forte pressione a decidere da che parte stare. Si tratta di esperienze formative che s’imprimono fortemente nelle menti e nei cuori dei partecipanti. È un’esperienza di maturazione collettiva, dove s’intuisce che un altro modello di società è possibile. Si fanno discussioni interminabili. Nascono giovani leader, in seguito agli incidenti, si creano i primi martiri. Vengono formulati gli obiettivi condivisi, che solitamente mirano a cancellare l’ordine ingiusto (sono gli obiettivi più facili e più capaci di aggregare) piuttosto che a costruire nei dettagli un nuovo ordine istituzionale. Si chiedono le dimissioni dei responsabili della repressione. Si chiedono governi provvisori. Si chiedono elezioni, soprattutto si chiede una nuova costituzione. Spesso l’impatto del movimento è tale che l’obiettivo sembra a portata di mano. Vengono fatte delle concessioni alla piazza, si aprono delle trattative. Il tentativo di cancellazione dell’ordine ingiusto riesce, oppure ci si va molto vicino. Qualcuno dei più impresentabili si dimette.
Proprio quando sembra che la piazza abbia vinto, cioè sia riuscita a imporre la propria visibilità, a imporre la propria agenda, a interessare i media a livello mondiale, entrano in scena altre componenti organizzate che mirano a usare, a stravolgere, oppure a combattere il movimento della piazza. La tipologia di queste componenti organizzate è quanto mai varia e dipendente dalle specifiche situazioni: vecchi partiti di opposizione che possono cercare di influenzare la piazza o di sostituirvisi (tipico è il caso dei Fratelli Musulmani in Egitto), gruppi estremisti (sia favorevoli che contrari alla piazza), l’esercito o frazioni dell’esercito, gruppi clandestini armati, organizzati secondo linee tribali, ideologiche o religiose, talvolta autoctoni, talvolta provenienti dall’estero. Non mancano i servizi segreti stranieri. Può accadere anche che si registri l’intervento paramilitare o militare di potenze straniere. Può accadere che la repressione sia così violenta da costringere la piazza a una reazione altrettanto violenta, dando così origine a una guerra civile, con tutte le incognite del caso.
Solo a questo punto la piazza, la cui natura è eminentemente prepolitica, si accorge di avere bisogno della politica. Ma difficilmente la trova. I partiti politici esistenti di solito sono immaturi, frammentati, rissosi. Molti dei loro leader sono corrotti o incapaci. Spesso si scontano anche i conflitti personali tra i diversi leader. Le varie frazioni di tutti i tipi preferiscono mantenere la propria purezza ideologica, la loro autonomia di azione, la loro indipendenza; mirano a espandersi a danno delle altre. Si possono realizzare alleanze temporanee che tuttavia risultano quasi sempre piuttosto deboli. Gli eventi, spesso poco controllabili, finiscono per spezzare gli schieramenti provvisori. Alla fusione globale sperimentata soggettivamente in piazza segue una disperata ricerca di identità che provoca il frazionamento e la divisione.
Può accadere che si organizzino elezioni (o referendum) e che si cerchi di produrre una costituzione. Le elezioni, in questi frangenti, sono quasi sempre borderline dal punto divista delle procedure democratiche e spesso vengono accusate di irregolarità e contestate. Spesso sono esperienze del tutto nuove, affrontate con grande ingenuità. Non si capisce mai bene quanto i risultati siano espressioni della volontà popolare, oppure di manovre e di strumentalizzazioni delle varie oligarchie che controllano i voti. Di solito, comunque, le elezioni portano al voto la popolazione più arretrata del paese (di solito molto più numerosa della popolazione delle città), proprio quella che non aveva partecipato al movimento. Perciò è facile che dalle elezioni il popolo della piazza esca sconfitto dal popolo silente delle periferie (la maggioranza silenziosa, come diciamo noi), che trionfino partiti legati ai vecchi blocchi di potere (Erdogan in Turchia ha vinto le elezioni, nonostante gli scandali personali e la violenta repressione effettuata a Istanbul). La prova delle elezioni rappresenta spesso una botta per la piazza. Essa si trova così di fronte all’alternativa di smobilitare e accettare di fatto un arretramento dei propri obiettivi, oppure di resistere contro l’arretramento, non riconoscendo la legittimità delle elezioni avvenute.
Qualora le nuove elezioni non contribuiscano alla costituzione di un potere stabile e riconosciuto (e ciò accade raramente), può subentrare una situazione di debolezza delle nuove istituzioni, d’incertezza, una situazione di tensione continua. Naturalmente l’incertezza politica contribuisce a rovinare l’economia e la finanza del paese in questione, le quali di solito già non si trovavano in condizioni floride, sottoposte alla rapina delle élite estrattive. Ciò provoca un impoverimento generale, scatenando accuse reciproche tra le forze della piazza e le forze conservatrici. In questa fase può facilmente accadere che la maggioranza silenziosa, la zona grigia, quelli che erano stati a guardare, prenda alla fine posizione. Di solito non si tratta di una posizione a favore della piazza. Ma può anche accadere che si costituiscano delle fazioni armate (appoggiate dall’esterno o dall’interno) e che quindi si scateni un processo di guerra civile. Lo scontro può dare luogo anche allo sviluppo di fazioni indipendentiste e quindi si può giungere anche a secessioni, separazioni (pacifiche o violente – si pensi alla Libia e all’Ucraina odierne). La cosa più facile che può accadere, nel protrarsi dell’incertezza e del disordine, (quella che è stata definita la situazione del vuoto di potere) che prenda piede un’ulteriore soluzione autoritaria (per un pronunciamento dell’esercito, per un colpo di mano dei servizi segreti, oppure per l’intervento di un paese straniero). L’alternativa che era stata posta dal movimento della piazza tra una società tradizionale e una società moderna si trasforma così in un’alternativa tra l’ordine e il disordine. Spesso le forze che mostrano di essere capaci di riportare l’ordine – magari a qualunque costo – riescono a ricevere sostegni aperti o nascosti dal contesto internazionale, riescono ad avere aiuti economici, oppure più semplicemente aiuti militari. Talvolta anche la neutralità esterna, giustificata talvolta da inconcludenti «tavoli di trattativa» internazionali, è sufficiente a permettere l’insediamento di un nuovo governo autoritario.
Agli osservatori esterni, nel momento dello stato nascente, pare che la comparsa della piazza costituisca la parte visibile di un enorme iceberg sotto la superfice. Abbiamo l’impressione che la società si sia già trasformata e che si tratti solo di travolgere le vecchie istituzioni e le vecchie élite che fanno resistenza. È un’illusione prospettica. Accade invece che la parte nascosta dell’iceberg sia costituita da una colossale sacca di arretratezza che attende solo il suo momento per manifestarsi. Dopo l’esplosione visibile delle minoranze attive, la pancia nascosta dell’iceberg tende a riprendersi il peso oggettivo che le spetta. Non si può combattere a lungo contro la forza di gravità. La comparsa della piazza dunque significa soltanto l’inizio possibile di un processo di cambiamento. Non offre alcuna garanzia circa l’esito finale. Dovremmo cominciare a chiamarle correttamente insurrezioni, più che rivoluzioni. È forte l’illusione che, con l’insurrezione di piazza, con le dimissioni dei vecchi regimi, il più sia stato fatto. Invece il più resta da fare. Ai vecchi regimi possono seguire nuovi regimi altrettanto vecchi, corrotti e spietati nella loro impostazione. Talvolta i nuovi regimi fanno rimpiangere quelli vecchi. Si pensi al caso Libia. Il caso Egitto sembra avviato nella stessa direzione.
Le maidan sembrano dunque piuttosto dei tentativi generosi, intrapresi da parte di ampie minoranze che cercano nell’azione di piazza di sviluppare e far crescere una propria identità sociale e politica. Si tratta di tentativi che certamente costituiscono di fatto delle straordinarie palestre di politica, scuole di alta formazione per un ristretto numero di individui. Si tratta di esperienze che tuttavia potranno dare i loro frutti forse solo dopo generazioni e generazioni. Sono testimonianze di frange che gridano al mondo la loro rabbia e la loro determinazione esistenziale. Quello che vediamo sempre più spesso sono le piazze senz’altro generose stritolate dagli opportunismi politici, dai professionisti dell’intrigo, ma anche dall’immaturità e dalle divisioni. Insomma le piazze stritolate dalla mancanza di maturità politica. Stritolate anche per la timidezza e le esitazioni delle potenze democratiche, che discutono e temporeggiano, mentre gli eventi precipitano. Certo, la politica in questi frangenti assai difficili dovrebbe avere il volto della partecipazione e dell’entusiasmo, ma anche il volto, assai più severo, della razionalità, del calcolo, della mediazione, della responsabilità. È difficile impersonare tutte e due le parti. La rivoluzione ucraina, ad esempio, non ha messo in conto l’estremismo fondamentalista della destra, non ha messo in conto i problemi etnici interni, l’intervento della Russia, l’impotenza dell’Europa e del resto del quadro internazionale e così ha fornito a Putin, su un piatto d’argento, la propria disgregazione nazionale.
Le parabole tipiche di questi movimenti, che abbiamo provato a sintetizzare, trovano dei riscontri anche nella nostra storia recente. Sembra proprio il caso di dire: «De te fabula narratur». Nel secolo appena trascorso, il Sessantotto ha rappresentato una prima maidan globale, nel mondo ancora fossilizzato dalla Guerra fredda. Il Sessantotto nel nostro Paese, nonostante gli sforzi generosi del movimento, non è riuscito a costruire una condizione di società democratica matura. Non è riuscito minimamente a incidere su quelle istituzioni che nell’immaginazione dovevano essere attraversate da una lunga marcia. Anzi, il movimento ha contribuito a rinvigorire e a generalizzare l’anti istituzionalismo tradizionale del nostro Paese e a metterlo a disposizione del nuovo blocco di potere che si formerà, caratterizzato dalla stretta congiunzione tra M&P&A. Dopo la manifestazione del movimento (nelle piazze, ma anche nelle istituzioni) si è avuta la frammentazione gruppettara, e alcuni gruppi hanno prospettato e praticato la lotta armata. Anche noi abbiamo avuto le nostre trame oscure, le nostre formazioni paramilitari di destra e di sinistra, le nostre infiltrazioni di potenze straniere, le nostre tentazioni autoritarie. Solo appena qualche tempo dopo, nasceranno anche le tentazioni scissioniste, l’avventura delle piccole patrie. Non ci siamo fatti mancare proprio nulla. Il ventennio berlusconiano ha costituito la vera rivelazione di tutte le nostre arretratezze, della nostra inconsistenza, della nostra incapacità a diventare moderni. La vera pancia dell’iceberg nostrano.
Le piazze dunque non cambiano davvero le società, anche se le piazze possono rappresentare dei momenti travagliati di crescita, possono essere dei sussulti a volte inevitabili, testimonianze preziose che (forse) potranno essere messe a frutto dalle generazioni future. Resta sicuramente l’amarezza per i sacrifici individuali che spesso risultano del tutto sproporzionati ai risultati ottenuti. Non di rado anzi le piazze, in termini di effetti perversi, possono creare le condizioni per un arresto, per un arretramento della modernizzazione (si pensi all’imbarbarimento che sta avvenendo in Siria). Spesso accade che solo i cambiamenti più superficiali che si realizzano nelle piazze vengono generalizzati e adottati dalla società più ampia. Si tratta solitamente di cose come l’occidentalizzazione dei consumi, la libertà sessuale, la laicizzazione di alcune componenti della società, e così via. Qualche intellettuale perseguitato poi magari si rifugia all’estero, a testimoniare l’oppressione del suo popolo, a ricevere premi nei festival cinematografici e nei concorsi letterari, certo con profitto per la cultura internazionale.
Le piazze spesso non riescono neppure a produrre, in un ragionevole lasso di tempo, il ricambio della classe politica. I leader che nascono nei movimenti delle piazze sono funzionali al movimento stesso e di solito non riescono a pesare più di tanto negli eventi successivi. Per usare un esempio che conosciamo piuttosto bene, in termini di formazione di una nuova classe politica i leader delle piazze del Sessantotto italiano non hanno prodotto granché. La loro successiva deriva politica (a destra, a sinistra – si pensi ai vari Ferrara, Curcio, Feltri, Capanna, …) mostra, oltre ogni dubbio, che alla base della cultura della piazza del Sessantotto, c’era solo una superficie di modernità, frettolosamente importata e fatta propria, mal digerita. Sulla base della vecchia cultura religiosa e/o contadina si erano innestate frettolose letture di tutte le ideologie politiche dell’Ottocento e del Novecento, dall’anarchismo allo stalinismo, e una concezione della democrazia ridotta alla spontaneità delle piazze, al movimentismo. Una democrazia che rifiutava il civismo e le istituzioni democratiche. Insomma, una cultura politica che mentre credeva di andare al di là, è rimasta al di qua della politica: sempre prepolitica, insomma. Si è trattato di un’esplosione intensa ma fuggevole, di un momento particolare della biografia dei singoli che spesso è stato ben presto rinnegato, dimenticato, messo da parte. Le ragioni dell’adattamento hanno prevalso sulle ragioni della fedeltà a se stessi, alla propria esperienza, alla propria causa. Certo, abbiamo evitato la guerra civile, ma il riflusso ce lo siamo goduto per intero.
Può darsi che la nuova mobilità internazionale e i nuovi mezzi d’informazione a livello globale possano oggi contribuire a far superare tutti questi limiti. Può darsi che i giovani leader dei movimenti che ogni giorno si formano nelle maidan del mondo, che subiscono generosamente i duri affronti da parte della pancia dell’iceberg, possano evitare di andare incontro ai processi di rapida obsolescenza, di riflusso, d’integrazione oppure anche di degenerazioni violente, nichiliste e autodistruttive. Può darsi che diventino leader maturi, consapevoli, riformatori, promotori di nuove e vitali democrazie. È solo una speranza. Le cose sembrano procedere in tutt’altra direzione.
02/05/2014
08/08/2014 (rev.)
Giuseppe Rinaldi
OPERE CITATE
1993 Huntington, Samuel P.
The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma Press, Norman. Tr. it.: La terza ondata. I processi di democratizzazione alla fine del XX secolo, Il Mulino, Bologna, 1991.
2012 Acemoglu, Daron & Robinson, James
Why Nations Fail, Crown Publishers, New York. Tr. it.: Perché le nazioni falliscono, Il Saggiatore, Milano, 2013.
NOTE
[1] L’occasione per scrivere queste osservazioni mi è stata suggerita dalla visione del film documentario The Square di Jehane Noujaim. Il film, seppure basato sul caso egiziano, mi pare costituisca un’illustrazione esemplare delle tesi che qui mi accingo a sostenere.
[2] Ad esempio, attraverso attività diplomatiche, attività dei servizi segreti, sanzioni economiche, interventi paramilitari o addirittura interventi militari diretti.
[3] Si veda in proposito Huntington (1993).
[4] Per la nozione di élite estrattive, vedi Acemoglu (2012).
[5] In Siria ad esempio, il primo movimento di opposizione è stato un tipico movimento di piazza. Solo successivamente la situazione è degenerata e sono comparse le formazioni armate.
[6] È esemplare il fatto che, in Turchia, il movimento curdo sia stato represso per decenni attraverso i tradizionali metodi repressivi dello stato autoritario. La recente rivolta di Istanbul, sebbene estemporanea e non organizzata, ha creato molte più difficoltà al regime. Ad esempio, è interessante che Erdogan, in contrapposizione alla piazza, abbia organizzato le sue proprie manifestazioni di piazza dei suoi sostenitori. È un riconoscimento implicito che qualcosa è cambiato.
[7] Questa situazione è ben nota agli studiosi dei movimenti collettivi. Si tratta dello stato nascente, che trova spiegazione sia nell’ambito della sociologia durkheimiana che in quello della sociologia weberiana.