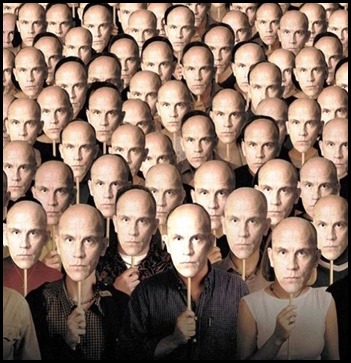
1. La folla solitaria[1] di David Riesman, è un celebre classico della sociologia, pubblicato nel 1950.[2] L’opera ha goduto di una notevole popolarità anche se poi è stata messa abbastanza rapidamente nel dimenticatoio, insieme alla corrente di studi alla quale faceva riferimento. Riletto a più di settant’anni di distanza, il libro di Riesman mostra indubbiamente i segni del tempo. Tuttavia alcuni suoi concetti di base, che all’epoca – col senno di poi – non erano stati del tutto ben compresi, oggi paiono straordinariamente di attualità e quanto mai illuminanti.
Essi si riferivano a fenomeni
psicologici e sociali che si trovavano ancora allo stato embrionale e che erano
osservati per la prima volta in alcuni settori della società americana. Più di
mezzo secolo fa, sotto l’occhio critico di Riesman e dei suoi collaboratori, si
stavano sviluppando le prime manifestazioni di un nuovo tipo di umanità che sarebbe stato poi destinato a diffondersi
e, forse, a soppiantare i tipi precedenti. I nuovi esemplari umani furono
interpretati come i conformisti,
oppure come i consumatori anonimi
delle società opulente, oppure come i
condizionati, gli schiavi della
pubblicità e della televisione, oppure, ancora, come il pubblico anonimo, evocato dallo stesso
titolo del libro, dell’incipiente società
di massa. A più di settant’anni di distanza, cominciamo solo ora ad
accorgerci che c’era ben altro in incubazione.
Può risultare allora decisamente
interessante una riconsiderazione dei concetti basilari di Riesman, per vedere
se e come questi possano essere utili per illuminare quel che sta accadendo
sotto i nostri occhi e che non riusciamo ancora – o che non riusciamo più – a capire.
Una riconsiderazione critica di Riesman può aiutarci, in particolare, a
comprendere le radici profonde di uno dei principali flagelli della nostra
attuale società e della nostra epoca, e cioè l’individuo ben socializzato.[3]
2. L’opera di Riesman apparteneva a un orientamento di studi che
fu denominato “cultura e personalità”
e che fu assai popolare, fino agli anni Settanta. Si trattava di un indirizzo
caratterizzato dalla fusione di concetti derivati dalla sociologia, dall’antropologia,
dalla psicologia sociale e dalla psicoanalisi. Il suo scopo principale era
quello di chiarire i rapporti tra le singole individualità e le rispettive
culture di appartenenza. Il concetto chiave, che doveva servire per connettere
la cultura e la personalità, era quello di carattere
sociale,[4] una nozione che Riesman aveva mutuato da Eric Fromm.[5]
Ne La folla solitaria David Riesman proponeva un’ambiziosa teoria,
sebbene talvolta un po’ vaga in alcuni passaggi, che faceva corrispondere ai
diversi gradi di sviluppo – di tipo demografico,
economico e sociale – una diversa strutturazione del carattere sociale degli individui. Trattandosi di una teoria causale, l’autore cercava di
individuare gli effetti delle trasformazioni economico-sociali (riferite in
particolare a quelle della società americana) sulla strutturazione interna
delle individualità (oggi potremmo
anche parlare di personalità, di identità personale, di Io o di self).[6] Ciò avrebbe permesso di cogliere le grandi tendenze di cambiamento
delle società contemporanee e, quindi, dei relativi caratteri psicologici. Per
realizzare una simile impresa occorreva avere a disposizione una tipologia di società e una
corrispondente tipologia di caratteri
sociali.
3. Il presupposto fondamentale della teoria di Riesman era funzionalista. Tutte le società, per
sopravvivere adeguatamente, hanno bisogno di mantenere un certo grado di conformità degli individui. Questo
risultato tuttavia può essere raggiunto in modi assai diversi. Riesman aveva
identificato, sulla scia di una serie di studi sullo sviluppo economico e
sociale allora in voga, tre principali modelli
di società che costituivano dei tipi
ideali, in senso weberiano. Si trattava di tre modelli di società che
risolvevano in maniera diversa il problema della conformità e, di conseguenza,
plasmavano il carattere sociale in modo alquanto diverso.
4. Il primo tipo individuato è la società tradizionale. Riesman qui ha in mente società assai
semplici, statiche, dove la mobilità sociale è ridotta al minimo. In questo tipo
di società gli individui, in gran parte, sono diretti attraverso la segmentazione della popolazione secondo tipi precostituiti, soggetti a norme
rigorose (in base a caratteristiche come sesso, età, ruolo svolto e così via). In
una simile situazione ogni individuo non può che adottare ed esibire il carattere sociale tipico del segmento
della popolazione di cui fa parte. Solo attraverso complessi rituali si può
passare da un segmento all’altro. Questi individui, così strettamente
determinati dal loro ruolo sociale, privi
di un’individualità differenziata, secondo Riesman sono diretti dalla tradizione. È questa una nozione assai prossima a
quella della solidarietà meccanica di
Durkheim.
5. Il secondo tipo è quello delle società mobili. Sono le società che attraversano una rapida fase di
trasformazione, di sviluppo ed espansione – com’è accaduto nel caso delle
società coinvolte nella rivoluzione industriale. Si tratta di società piuttosto
caotiche, dove l’ambiente sociale circostante è altamente imprevedibile. In
queste società, gli individui sono indotti, durante un lungo periodo consacrato
all’apprendimento, a interiorizzare un
complesso bagaglio formativo e a sviluppare poi, su quella base, la capacità
di agire efficacemente di fronte agli imprevisti e ai cambiamenti. Questi individui
saranno in gran parte autodiretti (inner-directed).
Questo significa che
essi, in un certo senso, portano con sé, nel loro bagaglio personale, tutti gli elementi caratteristici della propria
individualità. La conformità necessaria
è ottenuta quindi principalmente attraverso la trasmissione, in maniera
verticale, da una generazione all’altra, di un preciso tipo caratteriale. Gli agenti principali della formazione di questo
tipo di carattere sociale sono la
famiglia, le istituzioni religiose
e, più in generale, le istituzioni
educative. Le differenze individuali, se ci sono, sono dunque legate ai diversi curricoli formativi cui si è stati
sottoposti. Ciò che conta è che questi contenuti siano individualmente interiorizzati ed entrino a costituire proprio il
carattere sociale (che in tal modo risulta così costituire una parte comune della personalità
individuale). Il bagaglio culturale interiorizzato avrà continuità e stabilità,
e darà luogo a caratteri sociali ben riconoscibili e non facilmente
trasformabili. Simili individui, muniti del loro bagaglio interiore, saranno in
grado di mantenersi, in una certa misura, fedeli
a se stessi, nonostante il cambiamento anche turbolento che può avvenire
attorno a loro. Curricoli formativi diversi possono dare luogo a caratteri
autodiretti diversi e, quindi, possono fomentare anche tra loro conflitti di
vario genere.
6. Il terzo tipo di società è quello più recente, di cui si
avevano le prime avvisaglie quando Riesman scriveva, quello in cui si ha il
rallentamento della crescita economica e la diffusione di un relativo
benessere, pur senza diminuire la mobilità – è il caso delle società
industriali giunte allo stadio della loro maturità.[7] È un tipo di società
relativamente stabile, nel quale l’individuo è meno sottoposto a imprevisti e
cambiamenti, dove può usufruire di una relativa
abbondanza nell’ambito dei consumi e dove può moltiplicare a dismisura le proprie relazioni sociali. In questa
situazione, il tratto distintivo è il fatto che i legami con la formazione
ricevuta e interiorizzata nel primo periodo di vita tendono a indebolirsi e s’intensificano
invece i molteplici legami orizzontali
con coloro con cui si stabiliscono rapporti
interpersonali.
L’individuo si trova immerso
in una quantità di relazioni sociali che egli intrattiene con i suoi pari, sul
lavoro e nei momenti consumo e di svago. La conformità è ottenuta soprattutto
attraverso l’immersione continua nel flusso
delle comunicazioni e delle relazioni che si rinnova costantemente. È chiaro
che avere un bagaglio interno troppo rigido, in una simile situazione, diventa
uno svantaggio: il bagaglio personale deve dunque essere alleggerito e diventare flessibile,
in modo da consentire un adattamento
continuo ai flussi mutevoli delle comunicazioni e delle relazioni sociali.
Ciò crea una notevole
mutazione nel carattere. Il self o
identità personale, invece di essere il risultato di una trasmissione di tipo
verticale, ben strutturata al proprio interno e mantenuta saldamente per tutto
il periodo della vita (quello che tradizionalmente in Occidente si chiamava educazione), è ora sempre più dipendente
dalle relazioni orizzontali mutevoli che ciascuno instaura di volta in volta col
proprio mutevole ambiente sociale. È dunque un’identità di tipo interattivo, un
abito che si mette e dismette secondo
le circostanze che sopravvengono. Il fine della maturazione individuale non sta
più tanto nel disporre di un’identità personale autonoma, continuativa e
spiccata, nel costruirsi una struttura
stabile e ricca al proprio interno, quanto piuttosto nell’estrema
adattabilità, nel saper stare sempre al posto giusto nel momento giusto, nell’essere,
in altri termini, sempre adeguati alle
circostanze.[8] Gli individui che possiedono queste caratteristiche sono
definiti da Riesman come eterodiretti,
ovvero other-directed.[9] Il senso
dunque del termine ha a che fare con la dipendenza
dall’ambiente sociale, non nel senso di una semplice adeguazione (cosa
peraltro tipica delle società tradizionali) bensì nel senso di una connessione
costante e continua, una integrazione
alle molteplici situazioni sociali che vengono a determinarsi. L’obiettivo sarà
quello dello specchio perfettamente adeguato alla situazione.
Riesman era convinto che
nella società americana fosse in atto, per effetto dello sviluppo economico e
sociale che aveva ormai raggiunto la maturità, un passaggio tendenziale dal carattere autodiretto al carattere
eterodiretto. Questo cambiamento era allora visibile soprattutto nelle grandi
concentrazioni urbane americane, ma sarebbe stato destinato a diffondersi
ovunque in concomitanza con le trasformazioni economiche e sociali. Si sarebbe
trattato di un passaggio che avrebbe cambiato completamente il volto della
società americana e del resto dell’Occidente.
7. La nozione di carattere
sociale utilizzata da Riesman è coerente con la psicologia e l’antropologia
del suo tempo. Secondo Riesman: «Il “carattere sociale” è quella parte del “carattere”
propria dei gruppi sociali rilevanti e – come afferma la maggior parte degli
studiosi di scienze sociali – prodotto dall’esperienza di tali gruppi. La
nozione di carattere sociale ci permette di parlare, […] del carattere di
classe, gruppi, regioni e nazioni».[10]
Un carattere sociale di
qualche tipo è necessario poiché ogni società, se vuol mantenersi tale, deve in
qualche misura assicurare la conformità dei propri membri. Riesman cita in
proposito Erich Fromm: «Affinché qualsiasi società possa funzionare bene, i
suoi membri devono acquisire un tipo di carattere che porti loro a voler agire nel modo in cui devono agire in quanto membri della
società stessa o di una sua classe particolare. Essi devono desiderare ciò che nei fatti è
oggettivamente necessario fare. La forza esterna viene sostituita da una costrizione interna e da quel
particolare tipo di energia umana che si incanala nei tratti caratteriali».[11]
Cambiando il tipo di
società, cambiano anche i modi attraverso i quali le diverse società si
assicurano la conformità. Questi cambiamenti sono considerati da Riesman come
delle vere e proprie rivoluzioni nel
rapporto tra individuo e società. Naturalmente occorre guardarsi da ogni
schematismo. Riesman precisa infatti che: «[…] nei fatti non può esistere un
oggetto come una società o un individuo completamente diretto dalla tradizione,
completamente auto o eterodiretto: ognuno di questi modi di conformità è
universale, e la questione è sempre l’intensità con cui un individuo o un
gruppo sociale si sostiene sull’uno o sull’altro di questi tre meccanismi. […]
Inoltre, poiché ognuno di noi è in grado di praticare tutti e tre i modi di
conformità, è possibile che, nel corso della vita, un individuo si sposti da
una forte dipendenza da una combinazione di essi verso un altrettanto forte
dipendenza da un’altra combinazione».[12]
L’aspetto importante
della teoria del carattere sociale di Fromm e Riesman sta nel riconoscere che
una parte importante di noi stessi, del nostro self, è strettamente legata alle modalità con cui ci rapportiamo –
nello stesso modo in cui lo fanno tanti altri simili a noi – alla società e
alla cultura in cui siamo immersi. È questa comune interazione che costituisce
un carattere sociale che è
perfettamente distinguibile nelle sue caratteristiche e nei suoi effetti.
8. Vediamo ora, con qualche maggior dettaglio e con le parole
stesse di Riesman, come si caratterizzano i tre caratteri sociali da lui individuati. Nel caso delle società
tradizionali: «[…] la conformità di un individuo tende a rispecchiare la sua
partecipazione a un particolare gruppo distinto in base all’età, a un clan o a
una casta; ed egli impara a comprendere e ad apprezzare quei modelli durati per
secoli e modificati solo leggermente dal susseguirsi delle generazioni. Le
importanti relazioni della vita possono essere controllate da regole rigide e
accurate, che i giovani imparano nel corso degli anni di intensa
socializzazione, i quali terminano con l’ammissione al gruppo degli adulti.
Inoltre la cultura, oltre dai suoi compiti economici, o come parte di essi,
fornisce il rito, la consuetudine e la religione per occupare e orientare gli
individui».[13] Il carattere sociale
risulta dunque del tutto omogeneo ai gruppi segmentali di cui l’individuo fa
parte. Gli individui sono il ruolo
che ricoprono di volta in volta.
9. La crisi della società tradizionale, l’avvento cioè della modernità, porta a una rivoluzione. Il
venir meno delle rigide strutture normative esterne sposta l’asse della direzione all’interno del singolo individuo. L’individuo
diventa allora principalmente diretto dall’interno o autodiretto. Secondo Riesman: «[..] La fonte di direzione per l’individuo
è “interiore”, nel senso che essa viene impressa nel corso dei primi anni di
vita da parte dei più anziani e diretta verso fini generalizzati, ma non di meno
inevitabili».[14] Questo implica che nel self
o nell’identità personale debbano accumularsi una notevole quantità di
contenuti, un vero e proprio bagaglio per
la vita che ciascuno deve mantenere, coltivare e sviluppare,
indipendentemente dalla situazione esterna che può ora essere la più varia e la
più mutevole.
Avendo un suo proprio bagaglio interno permanente e autonomo,
l’individuo è così messo in grado di affrontare un ambiente in continua
trasformazione. La variabilità accentuata dell’ambiente e la sua complessità fanno
sì che le linee guida del progetto vitale individuale si trovino al proprio interno e non più all’esterno. Questo tipo di
individuo è adatto per tutte quelle situazioni caratterizzate dalla mobilità,
dalla complessità e dalla concorrenza.
10. Quando la società, dopo un periodo di sviluppo, di
cambiamento rapido, si assesta e quindi l’ambiente torna a essere
principalmente stabile e prevedibile, in una situazione di ridotta
conflittualità e di relativa abbondanza, con un aumento della complessità, si
producono le condizioni per l’affermazione del carattere eterodiretto. Afferma Riesman: «Il tratto comune a tutte
le persone eterodirette consiste nel fatto che i coetanei rappresentano la
fonte della direzione per l’individuo; essi sono composti sia dalle persone che
conosce direttamente, sia da quelle con cui ha relazioni indirette, mediate da
amici o da mezzi di comunicazione di massa. Naturalmente, poiché la dipendenza
da tale fonte di orientamento si radica presto nella vita del bambino, essa è
una fonte “interiorizzata”. Gli obiettivi che le persone eterodirette
perseguono si spostano seguendo questa guida: sono soltanto il processo che
porta all’obiettivo e il fatto di prestare attenzione ai segnali provenienti
dagli altri che restano inalterati per tutto il corso della vita. Questo modo
di mantenere i contatti con gli altri permette un’elevata conformità
comportamentale che non si ottiene tanto esercitando il comportamento stesso
come nel caso del carattere diretto dalla tradizione, quanto piuttosto per
mezzo di un’eccezionale sensibilità nei confronti delle azioni e dei desideri
altrui».[15]
Aggiunge ulteriormente
Riesman che: «Mentre tutti desiderano e hanno bisogno di essere apprezzati da
qualcuno per qualche tempo, soltanto il tipo eterodiretto moderno fa di ciò la
sua principale fonte di direzione e l’ambito principale della sua sensibilità».[16]
L’identità personale dell’eterodiretto non è più costituita come un complesso
formatosi nel corso dell’educazione e individualizzatosi attraverso le
particolari esperienze personali. Molti elementi che prima erano caratteri
distintivi e facevano parte del bagaglio individuale sono ora collocati all’esterno, nel contesto
relazionale dei gruppi di riferimento cui l’individuo partecipa quotidianamente.
Non occorre più tanto guardare all’interno di sé, basta guardare fuori di sé. L’imperativo
categorico non è più collocato nell’animo del singolo, bensì si trova diffuso
nel milieu delle relazioni nelle
quali si è immersi.
11. I diversi caratteri sociali naturalmente sono efficaci poiché
gli individui fanno nei loro confronti un
forte investimento emotivo. Riesman ritiene che per evidenziare le
diversità fra questi tipi si possa prendere in considerazione il luogo del controllo emotivo e il diverso tipo di sanzioni che sono
implicate in caso di non conformità. Per il tipo tradizionale il luogo del
controllo emotivo è l’esterno. Per il
tipo autodiretto il luogo del controllo è l’interno,
mentre per il tipo eterodiretto il luogo del controllo è l’altro interiorizzato.
La sanzione per il tipo
tradizionale è costituita dalla vergogna
pubblica. La sanzione per il tipo autodiretto è costituita dal senso di colpa, la colpa per la
violazione della norma interiorizzata, mentre la sanzione per il tipo eterodiretto
è costituita da una diffusa inquietudine
che, con terminologia attuale, potrebbe essere definita come ansia da prestazione. L’ansia cioè di non essere in grado di adeguarsi a
quanto chiesto dal contesto relazionale in cui si è immersi. È importante
comprendere come l’ansia da prestazione non è vissuta come colpa (perché non c’è alcuna violazione di una norma
interiorizzata) ma come inadeguatezza a essere
come gli altri. Non è un mero copiare gli altri, ma trovarsi nell’impossibilità
di essere in modo significativo,
posto che il significato stia nell’essere
come gli altri.
È degno di nota, in
proposito, che nel campo della psicologia clinica sia stata osservata – negli
ultimi decenni – la progressiva sparizione della repressione derivante dal
senso di colpa e la diffusione sempre maggiore dell’ansia da prestazione.[17] Il problema
della prestazione sembra sia diventato una delle questioni centrali della
psicologia clinica degli ultimi decenni. Questo cambiamento sarebbe
perfettamente collimante con un passaggio, del carattere sociale modale, dall’autodirezione
all’eterodirezione.
12. Secondo Riesman, osservando lo sviluppo delle società in
progressione storica si può ritrovare una specie di lotta tra i caratteri: «Possiamo descrivere gli ultimi secoli della
storia occidentale come il graduale susseguirsi del predominio degli ultimi due
tipi. Il tipo diretto dalla tradizione lascia il posto a quello autodiretto e
quest’ultimo a quello eterodiretto. Le trasformazioni del tipo di società e di
carattere non avvengono ovviamente tutte in una volta».[18] Solo quando le
trasformazioni si sono accumulate e assestate è possibile rendersi conto che
qualcosa è mutato. È ovvio che la prevalenza
di un determinato carattere a discapito degli altri in una società costituirà
un elemento caratteristico di quella stessa società e potrà essere usata come elemento esplicativo per una varietà di
fenomeni.
13. La tipologia di Riesman in realtà non si limita alla definizione dei tre caratteri sociali che abbiamo descritto. Essa è più complessa poiché, oltre ai tre modi di conformità, e quindi di adattamento, sono previsti anche due modi diversi (anomico e autonomo) di esercitare ciascuna conformità. Si ricordi che il modo di conformità corrisponde sempre a richieste tipiche da parte della società. L’individuo può poi ancora rispondere in maniera diversa a queste richieste. Si veda la tabella seguente.
|
|
Adattato |
Anomico |
Autonomo |
|
Carattere tradizionale |
|
|
|
|
Carattere autodiretto |
|
|
|
|
Carattere eterodiretto |
|
|
|
All’interno di ogni tipo
di carattere sociale abbiamo in gran prevalenza i bene adattati (che mostrano quindi lo specifico carattere della loro
società in modo spiccato). Abbiamo poi, però, anche gli anomici, cioè quelli che interpretano in modo anomalo il modello di
adattamento prevalente nel loro ambiente, e poi coloro che sono invece autonomi, sono cioè in grado di
controllare consapevolmente e autonomamente il proprio tipo di adattamento.
Entrambi questi gruppi costituiscono per lo più delle minoranze o delle
eccezioni. Purtroppo Riesman non ha approfondito in dettaglio e in modo
sistematico i diversi tipi generati dall’incrocio tra le variabili della sua
tabella (alcuni dei quali, presumibilmente, possono anche essere del tutto
vuoti, come nel caso del tradizionale - autonomo).
14. Particolarmente interessante, nell’analisi di Riesman, è la
declinazione della nozione dell’autonomia
che non coincide per nulla con quella di autodirezione. Autonomi, in generale,
sono quelli particolarmente consapevoli del
loro specifico carattere sociale e che possono decidere, quindi, se e in quale
misura conformarsi e, soprattutto, come
conformarsi. L’autonomia costituisce dunque, in un certo senso, una regia di secondo livello che permette
all’individuo di monitorare la propria stessa adesione a un certo carattere sociale. Questa regia di
secondo livello probabilmente può essere ottenuta solo attraverso una sorta di riflessione autobiografica condotta
attraverso un uso del linguaggio per monitorare se stessi e i propri
comportamenti (quel che è chiamato inner
speech o, più recentemente nella psicologia sociale, self - monitoring). È una condizione che probabilmente si può
raggiungere più facilmente nel contesto di un livello elevato di istruzione o
in seguito a particolari esperienze di riflessione e meditazione su di sé.
Da ciò si evince come, per
Riesman, il carattere autodiretto non sia
necessariamente autonomo. Chi abbia una profonda formazione religiosa, ad
esempio, può essere fortemente autodiretto ma, non per questo, autonomo. L’autonomia
dunque, se ha senz’altro una sua premessa nel carattere autodiretto, richiede
un lavoro aggiuntivo da parte del singolo individuo. La nozione di auto o eterodirezione
si riferisce fondamentalmente al luogo
da cui scaturisce l’indirizzo verso la conformità. È la modalità attraverso cui
la società si assicura la conformità, mentre l’autonomia o l’anomia
costituiscono gli approcci attraverso cui il singolo individuo reagisce al modello di adattamento che
gli è riservato.
15. È interessante il fatto che una società di eterodiretti, invece di essere
depositaria di un preciso bagaglio formativo, di una tradizione da ereditare e
sviluppare, sarà invece aperta ai cambiamenti e alle trasformazioni che si
affermano a livello di massa (come nel caso delle mode); il bagaglio di ciascun individuo andrà soggetto a una
progressiva obsolescenza secondo gli sviluppi delle mode, degli stili, delle
preferenze. Per usare una metafora, è come se il bagaglio personale dell’autodiretto
fosse sostituito da un bagaglio
collettivo medio collocato e diffuso nell’ambiente relazionale di
riferimento. Il bagaglio collettivo medio, che va soggetto anch’esso a
cambiamenti, è dotato di un forte potere di attrazione nei confronti dei singoli.
Si cambia continuamente, ma si cambia tutti
insieme, tenendosi d’occhio continuamente.
Se questo è vero, il
caso dell’eterodiretto autonomo dovrebbe
risultare poco diffuso, poiché l’eterodiretto tende a porre il proprio nomos fuori di sé e quindi tende a
modificarsi costantemente avendo gli altri significativi come riferimento,
tende cioè a interiorizzare le novità e ad abbandonare ciò che non ha più
rispondenza nell’ambiente. Qualora attraverso un attento monitoraggio di sé
egli giunga a problematizzare la propria dipendenza dal suo milieu sociale diventerebbe
immediatamente in grado di filtrare consapevolmente le influenze. Non è
tuttavia impossibile ipotizzare che ci sia un’eterodirezione
vissuta con lucida consapevolezza, con perfetta cognizione di causa.
È il caso di notare che
il carattere sociale di Riesman è una
disposizione appresa e quindi mutevole all’interno dello stesso
individuo. Entro certi limiti il carattere sociale può andare soggetto a
cambiamenti. Quando i cambiamenti individuali vanno tutti nella stessa
direzione allora diventano tangibili, tanto da caratterizzare un certo ambiente sociale.
16. La teoria di Riesman ha un’interessante conseguenza nella
interpretazione della stessa nozione di individualità
che è una delle caratteristiche più tipiche della civilizzazione occidentale.
Gli autodiretti tout court sono
coloro che, avendo ricevuto una formazione precisa, l’hanno interiorizzata e ne
hanno fatto la fonte costante e permanente delle loro scelte. Ciò permette una
situazione di grande omogeneità tra
coloro che hanno ricevuto la stessa formazione. Gli individui si assomigliano
non perché interagiscono continuamente l’uno con l’altro ma perché hanno lo
stesso bagaglio interno. Questa condizione è la base per la formazione e il
mantenimento dei gruppi religiosi o
dei gruppi ideologizzati. Insomma, le
ideologie (comprese le religioni) tendono a formare gruppi ampi e permanenti
ove gli individui siano dotati di un carattere sociale omogeneo. In queste
comunità ci sarà una forte pressione per
la conformità autodiretta ove, di conseguenza, i devianti non saranno bene
accetti e gli e autonomi potrebbero essere oggetti di sospetto. Queste comunità
sono costituite da coloro che, in un certo senso, sono di fatto depositari di una stessa tradizione culturale
(sia una tradizione di famiglia, che di fede religiosa, che di militanza
politica).
Max Weber ha
perfettamente interpretato questa situazione attraverso le sue celebri analisi
sul carisma (che corrisponde al
momento dell’autonomia) e sull’istituzionalizzazione
del carisma, che corrisponde al momento della riproduzione di individui
autodiretti che portano dentro di sé l’insegnamento carismatico e che
contribuiscono così alla sua istituzionalizzazione. L’epoca dei movimenti,
delle religioni e delle ideologie, almeno in Occidente, si è dunque basata sul
tipo di conformità assicurato dalla perpetuazione del carattere autodiretto.
Dovrebbe essere abbastanza chiaro il rapporto teorico e concettuale che viene a
instaurarsi tra l’avvento del nuovo carattere eterodiretto e la tanto discussa fine delle ideologie.
17. Come anticipato in apertura, i concetti di carattere sociale, di autodirezione, di eterodirezione e di autonomia,
elaborati da Riesman ormai più di sessant’anni fa, possono risultare ancora,
soprattutto oggi, di estrema attualità e possono risultare quanto mai utili per
interpretare una serie di processi sociali e culturali che sono diventati
evidenti soltanto negli ultimi decenni del Novecento, cioè in quell’epoca in
cui le società occidentali hanno cominciato a definirsi a torto o a ragione –
attraverso le elaborazioni dei loro stessi intellettuali – come società postmoderne. Del resto, nella
sua prospettiva storico sociologica, Riesman aveva previsto l’avvento di un cambiamento epocale, costituito dalla
progressiva sostituzione del carattere autodiretto con il carattere
eterodiretto, cosa che sarebbe stata possibile dalle trasformazioni di tipo
demografico, economico e sociale. Ovviamente Riesman non era ancora in grado di
apprezzare il ruolo, in questo cambiamento, degli sviluppi delle tecnologie
dell’informazione.
Proveremo in quel che
segue a sviluppare alcune linee generali di analisi che ci permetteranno,
grazie alle categorie di base di Riesman, di interpretare sotto una luce nuova
diverse questioni assai problematiche che oggi ci preoccupano alquanto. Si
tratta di questioni che solitamente sono state rubricate sotto la categoria
generale di una mutazione antropologica
degli individui che popolano le società occidentali. Il termine “mutazione
antropologica” – detto per inciso – pare sia stato usato per la prima volta da
Pasolini, anche se egli lo riferiva a tutt’altre problematiche.
18. Secondo la concezione classica più diffusa della modernità
e della modernizzazione, col
trascorrere del tempo avremmo dovuto assistere, nei termini di Riesman, alla
progressiva sparizione del carattere tradizionale e alla progressiva affermazione
del carattere autodiretto e, più specificatamente, del carattere autodiretto autonomo. Gli autodiretti
autonomi, infatti, sono sempre stati considerati come il tipo umano
indispensabile per l’affermazione di tutte quelle caratteristiche considerate
come progressive e tipiche del mondo moderno, come la laicità, la
secolarizzazione, lo sviluppo della scienza e della tecnologia, lo sviluppo
economico e sociale, l’affermazione dei diritti umani, del pluralismo e della democrazia.
Il carattere autodiretto autonomo è, insomma, quel carattere sociale che è
strettamente connesso con la realizzazione dell’ideale umanistico e, più in particolare, della classica idea guida dell’emancipazione umana. Persino l’ideale marxiano
dell’uomo comunista (non si considerino qui le degenerazioni) corrispondeva a un
modello di uomo autodiretto e autonomo. Gli autodiretti autonomi hanno costituito,
per secoli, il modello umano per eccellenza, l’obiettivo stesso della civiltà
occidentale.
Gli eterodiretti, come
Riesman li ha descritti, costituiscono invece qualcosa di molto diverso, una
vera e propria rottura in quello che si era creduto dovesse essere il destino antropologico dell’Occidente o
addirittura dell’umanità. Secondo la visione classica della modernità, gli
eterodiretti sarebbero decisamente antimoderni
e probabilmente anche antioccidentali.[19]
Insomma, nell’interpretazione classica della modernità occidentale, gli eterodiretti non erano proprio stati previsti.
Se erano stati in qualche modo considerati, lo erano stati come modello
negativo, un modello di uomo imperfetto, di uomo alienato, da superare. Gli
eterodiretti odierni non sembrano invece proprio degli autodiretti ancora immaturi, in fase di crescita,
che aspirano a diventare autodiretti autonomi. Sembrano invece avviarsi a
costituire un modello umano alternativo,
una specie di ramo evolutivo del
tutto incompatibile con il precedente. Un modello autosufficiente, capace di
affermarsi e generalizzarsi e soprattutto di fare a meno del modello precedente.
19. Questa nuova situazione sarebbe stata resa possibile proprio
dallo sviluppo e dalla modernizzazione prodotti originariamente
dagli autodiretti. Per la prima volta nella storia dell’Occidente, seguendo
Riesman, lo sviluppo economico sociale e culturale sembra avere reso possibile
un nuovo tipo di carattere sociale capace
di rendere superflui, o addirittura controproducenti, gli autodiretti stessi e,
in particolare, gli autodiretti autonomi. La stabilità raggiunta delle diverse società,
la loro relativa ricchezza, la crescita dei consumi, la diffusione delle nuove
tecnologie e dei social media hanno
permesso la costituzione di un nuovo tipo di tessuto sociale incentrato intorno alle relazioni, dove i rapporti
interpersonali, potenziati dai social
media, sono ora in grado di assicurare
la conformità e di fornire tutte le remunerazioni necessarie e le eventuali
sanzioni per i comportamenti anomici. Detto in altri termini, sarebbe recentemente
avvenuto, nel campo delle relazioni sociali, lo stesso processo di
autonomizzazione avvenuto secoli fa nel campo delle relazioni economiche con il
mercato. Si sarebbe cioè realizzata e
diffusa una gigantesca mano invisibile,
in grado di regolare in modo automatico
le interazioni sociali a partire dall’esterno
dell’individuo e non più dall’interno.
In questa nuova
situazione il carattere autodiretto, cioè
il carattere regolato principalmente dall’interno, diventa tecnicamente superfluo. Esso così, lungi dal costituire il modello più autentico dell’umanità,
come avevano pensato gli antichi e i moderni, è ora ridimensionato a una delle diverse
possibili strategie per assicurare la conformità, una strategia tra le tante che
è stata caratteristica precipua di una certa epoca storica e che si trova ormai
in via di abbandono.
20. L’obsolescenza
progressiva del carattere autodiretto, che peraltro si può osservare sempre
più frequentemente,[20] non è stata imposta da nessuno, si è diffusa spontaneamente,
appena se n’è presentata la possibilità tecnica, ed è stata accolta
trionfalmente dal pubblico. Ha avuto il senso di una liberazione da limitazioni
e costrizioni. Al di là di ogni aspetto specifico, l’abbandono è dovuto principalmente
al fatto che la produzione dell’autodiretto
è scomoda; è un processo lungo e dagli esiti incerti e non è affatto
divertente. Comporta un notevole dispendio di energie, un cospicuo
investimento, un notevole impegno e, soprattutto, una certa sofferenza a livello individuale. Questa
caratteristica, decisamente penosa,
della costruzione dell’autodirezione è bene espressa dalla parola disciplina. Freud ha condensato seriamente
il costo di produzione del carattere
autodiretto attraverso il suo concetto del disagio
della civiltà. Max Weber, dal canto suo, ha sottolineato la stessa
problematica attraverso le nozioni della vocazione
e dell’ascetismo.
La produzione degli
eterodiretti – che solo ora sta diventando tecnicamente possibile in termini di
automatismo sociale – confrontata con quella dell’autodirezione, è decisamente
assai più soft, assai più friendly. In altri termini, si può ora fare a meno di un vero e proprio disciplinamento interiore fin dalla più
tenera età. Non serve più spendere una vita per costruire e manutenere il
proprio bagaglio interno. Non c’è più
bisogno della selezione e di apparati repressivi espliciti. La
conformità necessaria è ottenuta principalmente intrappolando gli individui
nella rete ormai onnipresente e onnipotente delle relazioni interpersonali, reali o virtuali che siano. L’integrazione
sociale avviene così in modo spontaneo – più o meno come avviene l’apprendimento
della lingua materna – e ha il vantaggio di essere immediatamente gratificante, poiché si ha sempre un’immediata
risposta da parte di coloro che sono coinvolti nella relazione. È questa la
realizzazione paradossale del sogno della pedagogia
anti autoritaria.
21. Detto in altro modo, il centro di gravità del self eterodiretto non è più la
dimensione privata dell’individualità
bensì l’insieme delle relazioni esterne.
L’imperativo categorico diluito nella socialità. Siamo cioè alla presenza di un’ipertrofia
della dimensione sociale del self che sopravanza a dismisura la parte privata individuale (quella che si
chiamava intimità spirituale). Foucault ha descritto una simile situazione in
modo particolarmente fosco, evidenziando e analizzando gli elementi di potere coercitivo che si trovano diffusi
nelle relazioni interpersonali e nelle istituzioni sociali e culturali. A
differenza di Foucault, si tratta semplicemente di assumere che il potere del sociale
non abbia soltanto un lato repressivo,
bensì anche un lato costruttivo, un
lato di edificazione del self, capace
di fornire una remunerazione immediata
e di indirizzare in modo soft. Una remunerazione sociale che è ora
perfettamente in grado di sostituire l’auto remunerazione differita tipica invece
dell’autodiretto.[21]
Essere sempre in contatto con un ambiente
sociale con cui si ha un continuo scambio di remunerazioni più o meno immediate
riempie l’esistenza, la rende tutto sommato più facile e meno problematica. Le
dinamiche affettive nei confronti delle persone (presenti o virtuali) sono
molto più soddisfacenti degli investimenti emotivi che in precedenza si
dovevano fare nei confronti di cifre, simboli, concetti e sistemi astratti. Basta
lasciarsi guidare dalla trama delle relazioni, che fornisce in modo auto
evidente il significato delle
situazioni, di tutto quel che avviene e di tutto quel che si sta facendo. Che svolge,
dunque, anche una potente funzione
normativa.
22. Ciò può soltanto ora funzionare perfettamente, poiché il tessuto relazionale (entro cui entrano
molti individui singoli, molte situazioni) è ormai diventato estremamente denso
e onnipervasivo. L’individuo ben integrato
è, infatti, tutt’uno con questo
tessuto relazionale. Tutti gli sforzi individuali sono dunque indirizzati a
immergersi sempre più nel mare delle relazioni, in modo da giungere a
massimizzare tutte le proprie chance.
Tutto ciò però fa sì che il bagaglio
privato del self si riduca sempre
più. Christopher Lasch ha elaborato il concetto di un Io minimo.[22] Si è sempre più presenti sulla piazza pubblica delle
relazioni, alla quale è demandata la maggior parte delle decisioni, e sempre
meno nel proprio foro interiore.
Prova ne è che, quando per qualche motivo il tessuto relazionale viene meno, l’individuo
eterodiretto si trova depauperato della parte principale del proprio self, senza avere un suo self indipendente. Questo lo porta, come
un animale domestico che ha perso il padrone, a cercare immediatamente un altro
ambiente relazionale sostitutivo,
senza il quale non saprebbe più come fare. Si può in tal modo passare
continuamente da un ambiente relazionale all’altro, senza sviluppare mai un self auto sostenuto e indipendente.
Un self indipendente (che, come abbiamo osservato, è costoso e penoso) diventa così superfluo,
un vero e proprio spreco, quando vi sia un’abbondante offerta di situazioni
relazionali in cui infilarsi e soggiornare eternamente. In fondo basta avere l’agenda
piena di scambi, incontri, comunicazioni. Quando l’offerta relazionale è
abbondante, quando sopravanza grandemente il tempo disponibile, si può saltare
da una relazione all’altra senza accumulare alcun bagaglio, senza produrre
alcuna sintesi, senza alcun elemento critico – mettendo anzi accuratamente da parte ogni elemento critico – senza
alcuna presa di distanza. Un continuo esserci,
stando immersi beatamente nella corrente. È questa la famosa deiezione descritta da diversi filosofi
esistenzialisti.
23. Sembra così che, seguendo le intuizioni di Riesman, l’uomo nuovo del prossimo millennio non
sia destinato a essere il prodotto dell’autodirezione e dell’autonomia. Non sia
un prodotto dell’evoluzione culturale, avvenuta in seguito all’affermazione di
qualche religione o di qualche ideologia. La genesi dell’uomo nuovo prossimo venturo
sembra destinata a essere decisamente assai più prosaica. Nel momento in cui, nell’esperienza
quotidiana, diventa di per sé evidente che la
faticosa conquista dell’auto direzione è un’inutile sofferenza, magari una
pratica legata a tempi passati assai più bui, che è tempo sprecato, che si può vivere benissimo senza, e che si può
ottenere immediatamente una quantità di risposte emotivamente gratificanti immergendosi
nel mare sovrabbondante delle relazioni – ecco che allora si è pronti per l’amputazione
preventiva della parte più privata e personale del proprio self, per relegarla in un angolo, per zittirla, per non darle
alcuna possibilità di crescita. Il tutto per non disturbare il lavorio della mano invisibile del mercato delle relazioni
sociali che intanto è sempre all’opera.
24. Pur non rientrando nell’economia di questo saggio, lascio al lettore il compito di una seria meditazione su quali potrebbero essere le conseguenze politiche della diffusione su vasta scala del carattere eterodiretto. Si tratta di conseguenze sulla opinione pubblica, sulla cultura civica, sulla cultura politica e sulla vita politica stessa delle democrazie occidentali. Non sembra proprio del tutto infondato, allora, seguendo l’intuizione di Pasolini, parlare di mutazione antropologica. Questo è quanto ci aspetta. Questo, ahimè, è, e sarà sempre più, l’individuo ben socializzato, quello che in Occidente, in quest’ultimo mezzo secolo, è stato l’obiettivo formativo prevalente delle famiglie e delle istituzioni, cioè quello che si esprime e comunica continuamente ma che non ha più nulla di proprio da esprimere e comunicare.
Giuseppe Rinaldi (5/02/2017 – rev. 22/08/2025)
OPERE CITATE
1998
Brown, Jonathon D., The Self, Mc Graw
Hill.
1941
Fromm, Eric, Escape From Freedom,
Holt, Rinhearth and Winston, New York. Tr. it.: Fuga dalla libertà, Comunità, Milano, 1963.
2004 Gallino, Luciano, Dizionario di sociologia (2a edizione), UTET, Torino. [1978]
1984
Lasch, Christopher, The Minimal Self.
Psychic Survival in Troubled Times, Norton, New York. Tr. it.: L’io minimo. La
mentalità della sopravvivenza in un’epoca di turbamenti, Feltrinelli, Milano,
1985.
2010 Recalcati, Massimo, L’uomo senza inconscio. Figure della nuova clinica psicoanalitica,
Raffaello Cortina, Milano.
1969
Riesman, David & Glazer, Nathan & Denney, Reuel, The Lonely Crowd, Yale University Press, New Haven and London. Tr. it.: La folla solitaria, Il Mulino, Bologna,
1999. [1950]
NOTE
[1] Questo saggio è apparso per la prima volta sul mio blog Finestre Rotte nel 2016, con il titolo de L’individuo ben socializzato. Esso ha avuto diverse revisioni successive. La presente versione, con il titolo leggermente modificato, deriva da una revisione effettuata a partire dal 22/08/2025.
[2] Cfr. Riesman et Al. 1969 [1950]. L’opera,
oltre a Riesman, è attribuita ad altri due coautori, Glazer e Denney,
appartenenti al team di ricerca. Qui
si seguirà l’uso corrente di citare il solo Riesman quale autore principale. Il
titolo The Lonely Crowd, a quanto
pare, era stato imposto dall’editore. Anche se esprime qualcosa del contenuto
del libro, ha contribuito ad avvalorarne un’interpretazione riduttiva.
[3] Qui il termine socializzazione è utilizzato secondo il senso comune che ha assunto
nella seconda metà del secolo scorso. Originariamente il termine aveva avuto un
utilizzo accademico ed era pressappoco sinonimo di inculturazione. Stava cioè a indicare quel processo attraverso il
quale un individuo apprende la propria cultura. Solo nella seconda metà del
Novecento, sull’onda della pedagogia progressista sviluppatasi sulle due sponde
dell’Atlantico, il termine ha cominciato a essere usato nel senso di sviluppo delle abilità sociali e relazionali.
Insomma, da allora i “socializzati” sono i particolarmente socievoli, qualsiasi
cosa ciò stia a indicare. Secondo quest’accezione, un eremita che, grazie alla
sua inculturazione religiosa perfettamente riuscita, decida di passare la vita
da solo, in penitenza e preghiera, sarebbe dunque poco socializzato.
[4] Sulla nozione di carattere sociale vedi, in generale, Gallino 2004.
[5] Cfr. in particolare, Fromm 1941. Fromm, come
altri francofortesi, era migrato in America in seguito all’avvento del nazismo.
[6] Dagli anni Settanta la psicologia sociale ha
compiuto notevoli progressi nella ricerca intorno al self. Una panoramica di questi risultati si trova in Brown 1998.
[7] Riesman scrive nel 1950. Un paio di decenni
dopo comincerà a diffondersi la nozione di società
post-industriale. Lo studio di Daniel Bell sulla società post-industriale è
del 1973. Talvolta questo tipo di sviluppo è definito come società industriale avanzata, oppure come capitalismo maturo, o anche come affluent society. Più recentemente si è parlato di società postmoderna.
[8] Mentre l’autodiretto cerca soprattutto di
essere fedele a se stesso (per come
si è definito nel suo percorso di formazione e di crescita), l’eterodiretto
cerca di essere adeguato all’ambiente
sociale nel quale si trova. È come se la stabilità, che prima si dava per
scontato risiedesse dentro al singolo, sia ora collocata all’esterno,
nell’intreccio delle relazioni sociali in cui si è immersi..
[9] Negli anni ‘70, nel nostro Paese, questi
individui sarebbero stati definiti come “ben socializzati”. La sinistra
pedagogica è stata in questo caso vittima di un colossale errore, poiché ha
ritenuto di formare dei cittadini autonomi attraverso metodi pedagogici che al
più potevano essere adatti per la formazione di individui eterodiretti nel
senso di Riesman.
[10]
Cfr. Riesman et Al. 1969: 62.
[11]
Cfr. Riesman et Al. 1969: 63.
[12]
Cfr. Riesman et Al. 1969: 90-91.
[13]
Cfr. Riesman et Al. 1969: 69-70.
[14]
Cfr. Riesman et Al. 1969: 74.
[15]
Cfr. Riesman et Al. 1969: 81.
[16] Cfr. Riesman et Al. 1969: 82.
[17] Cfr. Recalcati 2010.
[18] Cfr. Riesman et Al. 1969: 92.
[19] Su questo punto vale la pena di formulare
un’osservazione, che qui non ho spazio per sviluppare, secondo cui gli
eterodiretti potrebbero avere alcuni punti in comune con le culture collettivistiche, soprattutto
con quelle orientali, come studiate da Hofstede e Triandis. Mi riprometto
eventualmente di tornare altrove sulla questione. In sostanza, l’individuo
occidentale ultra socializzato potrebbe manifestare alcune caratteristiche – ma
non tutte – delle culture collettivistiche orientali.
[20] Le evidenze empiriche che prospettano una
crisi o una progressiva sparizione del carattere autodiretto sono innumerevoli.
Esse coincidono con la progressiva crisi del modello umano inaugurato e
promosso dalla modernità. A mo’ di esempio – riservandoci eventualmente di
tornare sull’argomento – possiamo citare le principali tematiche filosofiche
proposte dal postmodernismo, la questione della fine delle ideologie, la crisi
degli intellettuali, il post-pensiero e la post-verità, gli attacchi sempre più
diffusi e popolari al pensiero scientifico, alla logica e alla razionalità. La
tematica della sparizione dell’uomo gutemberghiano e dell’affermazione del villaggio globale su cui ha insistito la
Scuola di Toronto. La questione delle
ipotetiche mutazioni antropologiche derivanti dalle nuove tecnologie e dai social media. La prevalenza dell’homo videns
descritta da Sartori. La crisi dei sistemi educativi occidentali, che
stanno rinunciando a qualsiasi tipo di formazione di caratteri autodiretti per
diventare centri di intrattenimento e
di “socializzazione”, cioè di iniziazione al carattere sociale eterodiretto. La
nuova configurazione dei disturbi psichici nella psicologia clinica, cui
abbiamo già accennato.
[21] L’autodiretto, seguendo la propria intima
direzione, è in grado di opporsi al proprio ambiente sociale immediato e di
scartare qualsiasi remunerazione per trovare una remunerazione in se stesso.
Solo così sono possibili le diverse forme di opposizione sociale. In un regime di ampia affermazione della
eterodirezione, l’opposizione sociale diventa alquanto improbabile.
[22] Cfr. Lasch 1984.
.